Questo pezzo è uscito originariamente su The Millions e viene qui riprodotto per gentile concessione dell’autore e della rivista.
di Adam O’Fallon Price
traduzione di Dario Matrone
Arrivai a rendermi conto che, più della trama e del significato convenzionale, per me era di gran lunga più importante il movimento in una precisa direzione che percepivo leggendo opere in prosa, la filigrana del tempo nel suo trascorrere, la macchina bianca della vita.
– Ben Lerner, Un uomo di passaggio
Nei corsi di scrittura creativa in cui insegno, i miei studenti – quasi tutti senza alcuna esperienza di scrittura narrativa – spesso si sbizzarriscono a inventare trame. La loro concezione della letteratura, derivata da un background di letture intensive di Stephenie Meyer/J.K. Rowling/Suzanne Collins (per non parlare di diciott’anni di serie televisive e film), è che in un libro bisogna che succedano delle cose. I loro primi racconti hanno un ritmo forsennato, sono pieni di matrimoni e divorzi e inseguimenti d’auto e sparatorie e scazzottate e omicidi e suicidi e omicidi-suicidi – a volte svariati nello stesso pezzo. Sono sceneggiature da film di serie B scritte in forma di prosa, in gran parte descrittiva.
Andate piano, gli consiglio, noiosamente. Ascoltano, o fanno finta di ascoltare, mentre spiego che la letteratura, il tipo di letteratura che a quanto pare sono pagato per insegnargli a scrivere, è questione più di personaggio che di trama. È un assioma: in letteratura il personaggio viene prima di tutto, sempre. Certo, devono succedere delle cose, ma può trattarsi di piccole cose, rotazioni minime delle migliaia di ingranaggi che costituiscono l’orologeria interna di un racconto. E dovrebbe trattarsi di cose che in ultima analisi derivano dal carattere del personaggio. I miei studenti annuiscono e si mettono a scrivere storie di vampiri pistoleri – vampiri pistoleri introspettivi, però – e prendono un A meno, con ogni probabilità.
Di recente, tuttavia, ho letto un mucchio di libri acclamati dalla critica, pubblicati negli ultimi anni, che mi fanno sentire come uno dei miei studenti. Dov’è l’azione?, mi chiedo, interrompendomi a metà lettura. Non fraintendiamoci, vengono scritti ancora tantissimi libri di trama, tantissimi best seller con la copertina che gronda sangue, ma inizio ad avere l’impressione che molti dei migliori romanzieri di oggi scrivano libri in cui non succede quasi letteralmente nulla.
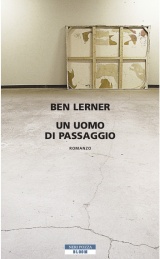 La citazione di Ben Lerner in esergo è tratta dal suo romanzo del 2009, Un uomo di passaggio. In questo libro, che ha il tono del roman à clef, Adam Gordon è un ventenne che vive a Madrid con una borsa di studio Fulbright e vaga per la città fumando erba, riflettendo sulla poesia, scrivendone pochissima, e dando di matto quando non dorme. In parole povere, è un poeta di vent’anni all’estero. Quei pochi eventi che ci sono, come l’attentato di Madrid cui rimanda il titolo originale [Leaving the Atocha Station], succedono a lui o intorno a lui, non grazie a lui. Verso l’inizio, per esempio, Adam si aggrega passivamente a un gruppo di stranieri in un bar, viene preso in simpatia da un madrileno socievole e da sua sorella, vomita per via dei troppi mojito, viene riaccompagnato a casa ma non ricorda l’indirizzo, viene portato a una festa, fuma troppa marijuana mentre ascolta uno che suona la chitarra, finge di piangere raccontando alla sorella del madrileno che sua madre è morta, e viene consolato da lei.
La citazione di Ben Lerner in esergo è tratta dal suo romanzo del 2009, Un uomo di passaggio. In questo libro, che ha il tono del roman à clef, Adam Gordon è un ventenne che vive a Madrid con una borsa di studio Fulbright e vaga per la città fumando erba, riflettendo sulla poesia, scrivendone pochissima, e dando di matto quando non dorme. In parole povere, è un poeta di vent’anni all’estero. Quei pochi eventi che ci sono, come l’attentato di Madrid cui rimanda il titolo originale [Leaving the Atocha Station], succedono a lui o intorno a lui, non grazie a lui. Verso l’inizio, per esempio, Adam si aggrega passivamente a un gruppo di stranieri in un bar, viene preso in simpatia da un madrileno socievole e da sua sorella, vomita per via dei troppi mojito, viene riaccompagnato a casa ma non ricorda l’indirizzo, viene portato a una festa, fuma troppa marijuana mentre ascolta uno che suona la chitarra, finge di piangere raccontando alla sorella del madrileno che sua madre è morta, e viene consolato da lei.
Forse qui un po’ di trama c’è, nel senso del comportamento ambiguo e fasullo di Adam, ma niente più di questo. Giriamo pagina ed ecco un nuovo giorno fatto di caffè bevuti sotto la doccia e passeggiate solitarie tra il Prado e Plaza del Sol e la Gran Vía. Si sottolinea più volte che Adam non sa parlare bene lo spagnolo, scelta narrativa che in apparenza tematizza i problemi di Adam rispetto alla poesia e alla rappresentazione letteraria, ma in pratica (ovvero a livello di trama) significa anche che il personaggio non è in grado di fare nulla di concreto. La sua capacità di agire è limitata in virtù di una ben precisa strategia narrativa, che dà invece massimo spazio ai suoi processi mentali, processi mentali che includono lunghe meditazioni sulla propria incapacità di agire.
Città aperta di Teju Cole utilizza questa stessa modalità ma fa un passo ulteriore, liberandosi quasi completamente della trama in favore delle peregrinazioni newyorkesi del narratore Julius. Questi «vagabondaggi», come vengono descritte nel primo capitolo, evidenziano anche la strategia narrativa del libro, in base alla quale l’evento reale di Julius che attraversa New York è soltanto un pretesto per farlo riflettere sulla città, sulla sua vita, sul mondo, sulla politica, come dice lui, «osservandosi mentre osserva».
La figura del flâneur non è certo una novità nei romanzi letterari, né lo è, più in generale, il fatto che l’azione principale si svolga nel pensiero. Per fare un esempio, cos’è Madame Bovary se non il ritratto di una donna che si osserva mentre osserva i propri veri sentimenti sulla vita e sul matrimonio? La differenza sembra essere che questi libri, e molti altri simili pubblicati negli ultimi anni, sentono ancor meno l’esigenza di far succedere qualcosa o di mettere i propri personaggi alla prova con qualche sviluppo della trama.
 Non si può parlare di libri privi di azione senza citare quel gigante incontrastato del tedio programmatico che è La mia lotta di Karl Ove Knausgård. Il ciclo del Min Kamp è un’ode all’inazione, un peana all’assenza di trama. La prima sezione del Libro Primo, circa duecento pagine, è dedicata al ricordo di un capodanno, durante il quale un Karl Ove adolescente e un amico rimediano una confezione da dodici birre, la nascondono nel bosco, poi vanno alla noiosa festa di un compagno di classe. Nient’altro. Il tutto è intervallato da digressioni sulla vita, la morte, la filosofia, la paternità – spesso interessanti – ma anche da altre digressioni che mostrano scene quotidiane, in gran parte di una banalità sfiancante (quante volte, per esempio, dobbiamo assistere alla scena di Knausgård che entra in una stazione di servizio e compra una Coca-Cola?). Anche la più ponderosa seconda metà del libro, che racconta la settimana di tempo tra la morte del padre e il funerale, si concentra perlopiù su cose che in teoria dovrebbero restare fuori dai romanzi: l’attesa di un volo, la pulizia del bagno, la pulizia della cucina, l’atto di indossare un paio di pantaloni – tutto questo descritto piattamente con un serioso tono eroicomico nordico.
Non si può parlare di libri privi di azione senza citare quel gigante incontrastato del tedio programmatico che è La mia lotta di Karl Ove Knausgård. Il ciclo del Min Kamp è un’ode all’inazione, un peana all’assenza di trama. La prima sezione del Libro Primo, circa duecento pagine, è dedicata al ricordo di un capodanno, durante il quale un Karl Ove adolescente e un amico rimediano una confezione da dodici birre, la nascondono nel bosco, poi vanno alla noiosa festa di un compagno di classe. Nient’altro. Il tutto è intervallato da digressioni sulla vita, la morte, la filosofia, la paternità – spesso interessanti – ma anche da altre digressioni che mostrano scene quotidiane, in gran parte di una banalità sfiancante (quante volte, per esempio, dobbiamo assistere alla scena di Knausgård che entra in una stazione di servizio e compra una Coca-Cola?). Anche la più ponderosa seconda metà del libro, che racconta la settimana di tempo tra la morte del padre e il funerale, si concentra perlopiù su cose che in teoria dovrebbero restare fuori dai romanzi: l’attesa di un volo, la pulizia del bagno, la pulizia della cucina, l’atto di indossare un paio di pantaloni – tutto questo descritto piattamente con un serioso tono eroicomico nordico.
Il carattere statico di questi libri non è casuale, anzi, è voluto, e in un certo senso ne è la ragion d’essere. Nella realtà come in Knausgård, non si dà epifania senza apofania. Così come il corpo di un uomo è composto prevalentemente di acqua, la vita di un uomo è fatta prevalentemente di attesa, di quei tempi morti che stanno tra un evento importante e il successivo. Ma la letteratura romanzesca, per come siamo stati abituati a considerarla da secoli, potrebbe essere definita nella sua essenza proprio come ciò che si occupa degli «eventi importanti». Tradizionalmente, la letteratura cerca di eliminare il contingente e l’irrilevante, i momenti tra i momenti, per creare una versione accelerata della realtà in cui cose relativamente importanti conducono ad altre cose relativamente importanti; non che nella vita reale non succedano cose importanti, solo che tra l’una e l’altra trascorre troppo tempo, e in questo tempo qualsiasi resoconto narrativo si perderebbe nella banalità, quella che Lerner, mutuando un’espressione di John Ashbery, definisce «la macchina bianca della vita».
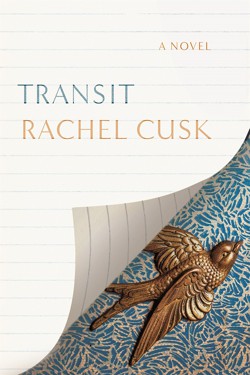 Perché, allora, alcuni dei più brillanti e celebrati scrittori del panorama letterario contemporaneo (tra loro inserisco anche Rachel Cusk, la cui trilogia incompleta – Outline, Transit – è uno studio sulla passività e l’apparente incidentalità degli eventi; in parte Elena Ferrante, la cui tetralogia napoletana acquisisce violenza e pathos attraverso infiniti, reiterati strati sedimentari; e anche Sheila Heti, nonché un’intera generazione di autori di cosiddetta non-fiction narrativa, fenomeno distinto ma strettamente collegato) raccontano storie in gran parte banali, che riguardano la macchina bianca della vita?
Perché, allora, alcuni dei più brillanti e celebrati scrittori del panorama letterario contemporaneo (tra loro inserisco anche Rachel Cusk, la cui trilogia incompleta – Outline, Transit – è uno studio sulla passività e l’apparente incidentalità degli eventi; in parte Elena Ferrante, la cui tetralogia napoletana acquisisce violenza e pathos attraverso infiniti, reiterati strati sedimentari; e anche Sheila Heti, nonché un’intera generazione di autori di cosiddetta non-fiction narrativa, fenomeno distinto ma strettamente collegato) raccontano storie in gran parte banali, che riguardano la macchina bianca della vita?
Un motivo (risposta purtroppo tipica a questo genere di domande retoriche) è internet. Trasformando il nostro modello di consumo delle notizie, da uno top-down, in cui le notizie filtrano dall’alto verso il basso, a uno à-la-carte, in cui ciascuno sceglie autonomamente da infiniti canali diversi, internet ha cambiato il modo in cui siamo abituati a ricevere e a diffondere le informazioni. Adesso informazioni di ogni tipo circolano tramite un sistema di nodi posti su un livello relativamente uniforme autorevolezza, e questo cambiamento, sebbene lo si osservi più spesso, com’è ovvio, dal punto di vista del giornalismo, non ha potuto non incidere anche sul nostro modo di leggere e scrivere i romanzi. Mettiamola così: William Shakespeare – o se è per questo Lev Tolstoj o Marilynne Robinson – sta a un padre del giornalismo televisivo come Edward R. Murrow come Teju Cole sta alla nostra timeline di Twitter.
È un paragone scontato, ma credo contenga una certa verità. In un’epoca di informazione verticale – grossomodo, la preistoria prima del 2005 – era naturale che i romanzieri scrivessero verticalmente. Nel diciannovesimo secolo, un periodo ancora religioso con un sistema giornalistico e editoriale consolidato, gli autori scrivevano con l’autorità caratteristica dell’epoca, con una fiducia nell’universalità delle loro osservazioni e dei loro giudizi: è una verità universalmente riconosciuta, tutte le famiglie felici si assomigliano, eccetera.
Anche dopo le rivoluzioni del ventesimo secolo, rimaneva una fiducia di fondo nel ruolo dell’autore come colui che porta le notizie. I postmodernisti come Thomas Pynchon, William Gaddis o Don DeLillo possono aver dubitato delle istituzioni del loro paese, modellando nuovi paesaggi di paranoia americana, ma avevano ben pochi dubbi o paranoie rispetto al loro ruolo di costruttori e interpreti di una realtà condivisa.
Come è stato osservato con fastidiosa frequenza sulla scia delle elezioni presidenziali, oggi noi abitiamo mondi separati in cui l’arte, le idee e la realtà vengono organizzate secondo criteri individuali. Forse esiste ancora una verità oggettiva, ma non è chiaro se sia possibile raggiungere un consenso su quale sia questa verità, così come sono sempre meno le persone di cui accettiamo per unanime consenso l’autorità. È noto che la parola autorità deriva da autore, e l’atto della scrittura è in sé stesso un atto di autorità: ci si arroga il diritto di creare e ordinare mondi e dunque di creare senso. Ma in letteratura esistono diversi gradi di ordine e di senso, e scrittori come Lerner, Cole, Cusk, Knausgård e molti altri, mi sembra, rispondono a questa temperie di incertezza – se mi è permesso usare un’espressione altisonante, questo indebolimento dell’autorità epistemica culturale – attenuando l’autorità che esercitano nelle loro storie; in generale, spostandosi dall’oggettività alla soggettività.
Ciò si manifesta in diversi modi, in primo luogo con la preponderanza del racconto in prima persona. La terza persona si arroga il diritto di parlare a nome di altri personaggi che non siano l’io narrante, di abitarli, e di manipolare questi personaggi, permeando il testo di una coscienza unitaria; la prima persona, a prescindere dal grado di artificio, presuppone una coscienza limitata, una separazione tra gli individui. E i racconti frammentari in prima persona – dai post di un blog al confessionale dei reality show ai tweet infantili del nostro presidente – sono di fatto la principale forma di racconto del nostro tempo. Non è difficile reimmaginarsi questi scrittori nei panni delle tipiche figure dei social media: Knausgård, il massimalista che condivide di tutto e di più; Lerner, l’ironico postmoderno; Cusk, la filosofa laconica; Heti, la più tradizionale diarista. (Per inciso, può darsi che a livello subliminale i lettori si sentano lusingati all’idea che una compilation dei loro status di Facebook e dei loro pensieri sulla vita potrebbe, con pochissimo lavoro di editing, dar forma a un romanzo pubblicabile.)
E questa autorità letteraria attenuata si manifesta anche in una tendenza all’assenza di trama e alla banalità. L’atto di inventare una storia è un atto di controllo, un tentativo di imporre un ordine sull’entropia. Maggiore la cura con cui si progetta una storia, maggiore la meticolosità con cui si dispongono a effetto gli eventi, più alto è il grado di controllo autoriale inteso in senso tradizionale. William Makepeace Thackeray, per esempio, nella Fiera delle vanità, imbastisce un racconto pluridecennale delle vite dei suoi personaggi, facendo muovere Becky Sharp e gli altri in un diorama, in cui ogni tanto si inserisce per commentare: Ecco cosa è successo a ciascuno, ed ecco perché. Viceversa, riprodurre la vita «così com’è» in questo genere di letteratura quasi memorialistica, implica una posizione di neutralità dell’autore, la rinuncia a qualsiasi pretesa di organizzare gli eventi per ottenere un effetto narrativo o a qualsiasi potere esplicativo: Ecco cosa è successo a me, e chi può dire perché?
Può anche darsi che, in una certa misura, soffriamo di un affaticamento culturale da trame. Cinque minuti di notiziario forniscono avvenimenti a sufficienza, abbastanza svolte drammatiche e vicende appassionanti da saziare il nostro appetito di surrogati romanzeschi. Qualsiasi adulto con un lavoro e uno smartphone è sommerso da una quantità senza precedenti di informazioni e pubblicità. C’è una competizione pressoché ininterrotta per conquistare la nostra attenzione, violando ogni giorno di più i limiti della privacy mentale: non possiamo prendere un aereo, salire su un taxi o fare un pieno di benzina senza vedere dei titoli in sovrimpressione che scorrono davanti ai nostri occhi esausti.
In quest’ottica, il romanzo senza trama può essere visto come una forma di resistenza culturale, un rifiuto di contendersi la scarsa attenzione del lettore tramite i brillanti, scintillanti artifici della trama. In termini di esperienza estetica, è anche una tregua – ho la sensazione che molti lettori provino piacere a lasciarsi cullare dai cumuli di neve dell’infanzia di Knausgård, dalla silenziosa calma prodotta dalla glaciale inazione del romanzo. In questi «tempi interessanti» (come dice il vecchio adagio), una risposta intelligente può essere quella di scrivere letteratura meno interessante.
© Adam O’Fallon Price. Tutti i diritti riservati.
Condividi

