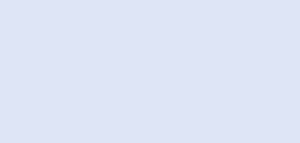 Catherine Lacey, autrice del romanzo Nessuno scompare davvero, racconta il suo rapporto con uno degli scrittori che ama di più, il poeta americano John Berryman, figura brillante e controversa le cui opere sono pressoché assenti dalle librerie italiane e che meriterebbe una riscoperta. Il pezzo è uscito originariamente sul blog della Paris Review, e viene qui riprodotto per gentile concessione della rivista e dell’autrice.
Catherine Lacey, autrice del romanzo Nessuno scompare davvero, racconta il suo rapporto con uno degli scrittori che ama di più, il poeta americano John Berryman, figura brillante e controversa le cui opere sono pressoché assenti dalle librerie italiane e che meriterebbe una riscoperta. Il pezzo è uscito originariamente sul blog della Paris Review, e viene qui riprodotto per gentile concessione della rivista e dell’autrice.
di Catherine Lacey
traduzione di Teresa Ciuffoletti
La mia collezione di libri di poesia è smilza ma include il mio libro più sfogliato: The Dream Songs di John Berryman, e fino a poco tempo fa mi leggevo diverse songs a settimana, ritornando sulle mie preferite come se contenessero un qualche indizio. Le leggevo per tirarmi su o per crogiolarmi nel malessere. Le leggevo ad alta voce, da sola e ad altri. Certe notti, dopo aver bevuto del vino, leggevo a voce alta le più cattive, le più strane. Quando trovavo una copia in libreria la aprivo su una delle mie preferite e la porgevo a qualcuno. Perfino le sue poesie più tetre, più atroci, più disperate mi confortano. I suoi versi si insinuano dentro di me per settimane.
Non è che penso che Berryman sia lo scrittore più bravo in assoluto o che abbia scritto le poesie più importanti o che la sua opera abbia raggiunto chissà quali vette dal punto di vista estetico, e non è che non ho niente di meglio da leggere. Nulla di tutto questo è vero, eppure mi sento spinta a leggerlo come non mi capita quasi mai con nessun altro scrittore. Sto ancora cercando di capire perché.
Una decina di anni fa ne ho quasi fatto indigestione durante un’estate passata a New Orleans. Mentre turbini di uragani avanzavano verso di noi dal golfo, le conversazioni lugubri al supermercato si confondevano nella mia estate all’insegna delle Dream Songs come latte versato in altro latte.
Una nota firmata J.B. sulla prima pagina del libro:
Il poema dunque […] riguarda essenzialmente un personaggio immaginario (non il poeta, non io) chiamato Henry, un americano bianco alla soglia della mezza età […] che ha subito una perdita irreversibile e parla di sé talvolta in prima persona, talvolta in terza, a volte persino in seconda persona.
Anche Berryman era un americano bianco alla soglia della mezza età che aveva subito una perdita irreversibile, che a sua volta si era riverberata in altre perdite irreversibili: amori perduti, amici perduti, sobrietà perduta, lui stesso alla fine perduto nel fiume Mississippi. Suo padre, John Smith, fece trasferire la famiglia dall’Oklahoma alla Florida quando Berryman aveva appena dodici anni e poco dopo si tolse la vita con un colpo di pistola, stramazzando di fronte alla finestra della camera da letto del poeta. Ben presto sua madre sposò un altro John, anche lui impiegato di banca, e il poeta prese il cognome del nuovo padre: Berryman.
Nel 1970 John Berryman, il poeta, trovò la fede in un Dio cristiano trascendente e due anni dopo andò incontro a questo Dio saltando giù da un ponte sul Mississippi. Aveva cinquantasette anni.
Quando tornai a New Orleans dopo l’uragano trovai casa in un vicinato con pochi vicini. I lampioni non si accendevano mai. C’erano sfilze di frigoriferi lungo gli spartitraffico, un esercito pronto a combattere un nemico inesistente. Andavo al lavoro in bicicletta in mattini umidi color blu scuro e ripetevo i suoi versi per farmi compagnia. «I don’t see how Henry, pried / open for all the world to see, survived» [«Non capisco come Henry, / spalancato a forza dinnanzi al mondo intero, sia sopravvissuto»].
Molti anni dopo cominciarono a spuntare su internet i video dei reading farfugliati e sbronzi di Berryman: il suo fantasma a quel punto era animato. Ma verso la fine del 2011 avevo già visto o ascoltato diverse volte ogni singolo reading, intervista, e discorso; il Berryman digitalizzato non mi bastava più: volevo tenere in mano la stessa carta che aveva tenuto lui, avvicinarmi ai suoi anni, vedere la sua firma scritta con l’inchiostro, proprio come la faceva lui. Valutai la possibilità di una visita all’archivio completo a Minneapolis, ma poi ripiegai sulla collezione più piccola della Columbia University, a qualche fermata di metropolitana da casa mia.
Ci trovai una fotografia di Berryman da giovane, sulla ventina, ben rasato, in completo bianco, con un sorriso da ragazzino. Feci una foto col cellulare e la misi come sfondo. («E quello chi è?», mi chiese qualcuno a un certo punto. «Non lo so», dissi io.)
Trovai una bozza scritta a mano della prefazione di Saul Bellow al romanzo incompleto di Berryman, Recovery.
Bellow: «Una volta mentre stavamo parlando di Rilke l’ho interrotto per chiedergli se qualche sera prima […] avesse spinto una donna giù per una rampa di scale…»
E Berryman chiede: «Chi?»
E Bellow risponde: «Catherine».
E io penso: Ah.
Berryman dice: «L’ho fatto davvero? Chissà perché».
E Bellow: «“Perché non ti voleva far entrare in casa”. Berryman mostrò un interesse cortese per questa informazione. “Il solo fatto di essere stato in città mi giunge nuovo”, disse. Tornammo a parlare di Rilke. C’era un solo argomento importante. Non chiacchieravamo mai del più e del meno».
Il sangue di Catherine e il suo naso rotto, l’ambulanza che gorgheggiando sfreccia verso di lei: chiacchiere per questi giganti.
***
Che Berryman e Bellow fossero stati colleghi, magari pure in buoni rapporti, lo sapevo, ma la crudeltà e la ristrettezza di vedute di Bellow hanno sempre limitato il suo fascino ai miei occhi: la sua scrittura, per quanto bella, trasuda pozze di misoginia pessimista molto più ampie di quelle che riesco a ricondurre alla sua generazione, al suo tempo. Per cui l’idea che Bellow e Berryman fossero stati amici mi dava un po’ fastidio. Ma poi m’immaginai un John Berryman ubriaco che spinge una povera donna giù per le scale, una certa Catherine, a New York. E la caduta per la scale non è la tipica scusa che si tira in ballo quando in realtà è successo tutt’altro?
Io ho rimediato un occhio nero il giorno che sono andata a vivere con l’allora-mio-ragazzo, ma è stata tutta opera mia: non si sa come sono riuscita a farmi cadere la base massiccia di una lampada sullo zigomo. Faceva scompisciare da quanto suonava improbabile: Ah, quel livido lì? Si è fatta cadere una lampada in faccia. Eppure le occhiate che mi lanciavano in fila al supermercato non erano tanto da scompisciarsi. Dietro a un occhio nero non c’è sempre una storia buffa. Non tutti riescono a scrollarselo di dosso, a rimettersi a parlare di Rilke.
Bellow racconta anche di aver trovato un Berryman in preda a dei postumi tremendi, steso a faccia in giù e immobile sul letto. «È tutta fatica sprecata. Per noi la rigenerazione è impossibile», disse Berryman, parlando di come le sue poesie non avrebbero mai potuto riscattarlo. A lui questa consapevolezza pesava come un macigno legato al piede, ma per Bellow era un aneddoto.
Uscii dalla libreria sentendomi incompatibile con la luce del sole. Pensai al fatto che Berryman si firmava con la J al contrario. Deve essersi sempre sentito al contrario. Mi chiesi chi fosse Catherine.
Qualche giorno dopo sconcertai il mio analista singhiozzando per un tempo esagerato, perché trovavo ingiusto trarre godimento dalle opere per cui quell’uomo aveva sofferto così tanto. Era come se fossi stata io quella buttata giù dalle scale, ma stessi, perlopiù, dalla sua parte.
Da un’intervista:
BERRYMAN: Be’, fare il poeta è una roba buffa. Non ti porta nulla. Non ti porta soldi, o comunque non tanti, e non ti porta nessun prestigio, o comunque non tanto. È una cosa che fai e basta.
INTERVISTATORE: Perché?
BERRYMAN: Questa è una domanda difficile. Le darò una vera risposta, prendo la sua domanda sul serio. È un passo di Hamann, citato da Kierkegaard. Ci sono due voci, e la prima voce dice: «Scrivi!» e la seconda voce dice: «Per chi?» Lo trovo meraviglioso; vede, l’imperativo in sé non viene affatto messo in discussione. E la prima voce dice: «Per i morti che amasti un tempo»; la seconda voce non mette in discussione neanche questo, ma chiede: «Mi leggeranno?» E la prima voce dice: «Sì, perché ritorneranno come posterità». Non è fantastico?
In un’intervista per la Paris Review fu chiesto a Berryman come rispondesse all’etichetta di poeta «confessionale» che gli veniva puntualmente affibbiata: «Con rabbia e disprezzo! Prossima domanda». Poi aggiunse: «È una parola che non significa niente, per me il confessionale è un posto dove uno va e parla con un prete. Personalmente non mi confesso da quando avevo dodici anni».
***
Da «Dream Song 145»:
rose with his gun and went outdoors by my window
and did what was needed
[si alzò con la pistola e si piazzò fuori, dalla mia finestra / e fece ciò che andava fatto]
Da Dream Song 384:
I spit upon this dreadful banker’s grave
who shot his heart out in a Florida dawn.
[sputo sulla tomba di questo orribile banchiere / che un mattino in Florida si sparò un colpo al cuore]
(non il poeta, non io)
Alcune ipotesi:
Sono ossessionata da Berryman e The Dream Songs perché la sua opera e la sua vita mi spaventano a morte, perché ho romanticizzato Berryman a tal punto che ormai è solo una storia che mi racconto, perché rispondo all’autosuggestione di essere ossessionata da The Dream Songs, perché sono lo spirito reincarnato di una donna che lui amava, perché la sua opera mi fa avvicinare alla vita in tutta la sua ruvidità e il suo marciume.
Quest’ultima mi sembra la più azzeccata, anche se continuo a non capire perché.
Da un’intervista:
Henry mi assomiglia, e io somiglio a Henry; eppure io non sono Henry. Cioè, io pago le tasse; Henry mica paga le tasse. E poi arrivano i pipistrelli e mi si attaccano ai capelli – e vaffanculo, io non sono Henry: Henry non ce li ha i pipistrelli in testa.
Le poche volte che ho pubblicato cose che parlavano di mie esperienze personali la gente mi ha detto: Eh, dev’essere stato catartico. Ma la scrittura non è catartica. La vera catarsi ha bisogno di un testimone o di un catalizzatore: non basta una pagina, non basta una mente isolata. La scrittura è un bozzolo compulsivo, e il suo unico vero beneficio sta in quei momenti in cui riesci a produrre qualcosa che ti avvicina agli altri. Il fatto di starmene qui seduta a scrivere in questo momento, di per sé, non soddisfa. Un’intensa giornata di lavoro non mi lascia nient’altro che il torpore nebuloso di un tossico che ha soddisfatto il suo bisogno di una dose: il punto è produrre qualcosa che renda la mia realtà più chiara ad altre realtà, e forse neanche quello è davvero il punto della questione.
La scrittura si muove inevitabilmente verso gli altri.
Ma il rapporto tra scrittore e lettore è incompleto per natura. Esiste in uno spazio vuoto che il primo riempie e il secondo riceve, proiettandoci sopra anche le proprie storie. Lo scrittore è il paziente. Il lettore è l’analista che cerca, volta le pagine.
Mi chiedo cosa direbbe Berryman a proposito della catarsi. Per quanto ne so io, non ne ha mai parlato.
E mi chiedo se Berryman sarebbe stato un poeta altrettanto bravo se avesse avuto un analista. Mi chiedo se si sarebbe ucciso se avesse ammesso che Henry era una sorta di riflesso di sé. Mi chiedo se pensava di ottenere una rigenerazione quando si schiantò sul fiume il 7 gennaio 1972.
Il 7 gennaio 1972 104 persone morirono in un incidente aereo a Ibiza e gli LA Lakers vinsero la loro trentatreesima partita consecutiva e otto bombe a orologeria nascoste in diverse banche d’America furono disinnescate dalle forze dell’ordine e il corpo di Berryman fece un volo di venti metri dal ponte all’acqua.
Solo di recente ho scoperto come funziona quel tipo di suicidio; è l’impatto, dicono: ti squarcia gli organi, può fracassare un cranio, invertire il flusso del sangue, strappare la pelle dall’osso, e a volte dopo aver letto Dream Songs mi sento in colpa per il gran piacere che provo: non dovrebbe piacermi tutta quell’oscurità, quei sentimenti lasciati incustoditi prima che il fiume lo facesse a pezzi.
O forse sto solo cercando di rendermi immune, di guardarmi dal diventare come lui, sempre più ritirato in sé stesso, dal giovanotto con il completo bianco di lino alla faccia dietro una barba incolta, con la voce ingrossata dal gin e lo sguardo altrove, a declamare poesie che non erano più un ponte tra lui e gli altri, ma un muro.
Al pubblico di un suo reading nel 1968:
Se fossi in voi serberei l’applauso per il finale. E poi mi tratterrei dal farlo.
© Catherine Lacey, 2013. Tutti i diritti riservati.
Condividi

