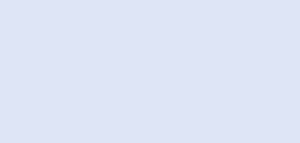 Questo articolo, uscito originariamente sul blog della Paris Review, racconta l’ispirazione che sta alla base dell’Infortunio di Chris Bachelder.
Questo articolo, uscito originariamente sul blog della Paris Review, racconta l’ispirazione che sta alla base dell’Infortunio di Chris Bachelder.
Ringraziamo autore e rivista per la concessione. Buona lettura!
di Chris Bachelder
traduzione di Francesca Pellas
Quando la mia bambina di dieci anni mi ha sentito dire a un amico che L’infortunio parla di un gruppo di uomini che si riunisce ogni anno a novembre per rimettere in scena l’azione in cui il quarterback dei Washington Redskins Joe Theismann subì un tremendo infortunio alla gamba, mi ha fatto una domanda.
«Papà», ha detto, con aria seria e perplessa. «Ho una domanda».
«Di che si tratta?», ho detto.
«Non è una cattiveria?»
«Non è una cattiveria che cosa?», ho detto. Confesso che non capivo cosa intendesse. Le avevo confuso le idee, e ora lei le stava confondendo a me.
«Non è una cattiveria, da parte di questi signori?», ha chiesto lei. «Commemorare il modo in cui uno si è fatto male?»
Be’, poteva sembrare una cattiveria, mi sono reso conto all’improvviso. Cioè, ho capito perché lei potesse vederla così. Sembra, in effetti, un alzare ulteriormente la posta rispetto alla cattiveria intrinseca al football. Non sembra solo una cattiveria ma qualcosa di crudele, di sadico. Sembra derisorio, un compiacimento spietato di fronte a un dolore vero. Che razza di uomini celebrerebbero questo rituale sprezzante? E che razza di papà inventerebbe degli uomini capaci di celebrare questo rituale sprezzante?
Mia figlia non pensa che io sia cattivo. Perlomeno non ancora. Mi rendevo conto che faticava a capire questa contraddizione. E voleva capirla.
Io ho riso, e immagino che anche la risata possa esser sembrata cattiva. Ho riso, credo, perché avevo afferrato l’incongruenza, la sproporzione. C’è un sollievo in questa cosa, come nel finale di una barzelletta. Mi sono reso conto di quali fossero i nostri due punti di vista, così come della notevole distanza tra loro. Era chiaro che la sua domanda aveva senso, e che anche se si sbagliava, dietro il suo errore c’era qualcosa di sfaccettato e interessante.
«Non è una cattiveria, tesoro», ho detto. «È difficile da spiegare, ma credimi, in quello che fanno questi uomini non c’è cattiveria. Al contrario».
Sono passati più di trent’anni da quando Theismann si procurò una tremenda frattura esposta alla gamba in seguito a un placcaggio da parte di Lawrence Taylor nel secondo quarto di una partita in diretta tv sul Monday Night Football. Io avevo quattordici anni, e avevo il permesso di vedere la prima metà delle partite del lunedì. Quella sera stavo guardando la tv da solo, e insieme a milioni di altre persone.
Ecco, questo è un fenomeno strano: ho notato che quando parlo di quell’azione con altri – soprattutto con uomini grossomodo della mia età – capita che facciamo versi e smorfie di dolore, e magari ci afferriamo la gamba senza volerlo, ma è anche probabile che ci ritroviamo a sorridere e annuire, persino a ridere. Che cosa c’è che non va in noi? A un altro essere umano è uscito un osso dalla carne in diretta nazionale: il ricordo di quest’evento non dovrebbe suscitare ilarità o pensieri nostalgici. Siamo tutti, in fin dei conti, semplicemente cattivi? E questa non è altro che la morte dell’empatia, la crudeltà disinvolta dei commentatori dell’era di internet?
O forse nel corpo c’è qualche verità. La risposta fisiologica potrebbe esprimere o svelare qualcosa di non detto. Quel ghigno, l’afferrarsi la gamba per scherzo: forse è una specie di palinsesto, la testimonianza di una stratificazione emotiva e temporale. In questa reazione vediamo coesistere due momenti. Non osserviamo solo la fredda brutalità dell’azione originale – l’incubo al rallentatore del replay in controcampo, lo shock di Taylor che si porta le mani sul casco – ma anche il il potere lenitivo degli anni trascorsi. Vediamo l’identificazione e il conforto dati dall’appartenenza a un gruppo, la fitta malinconica della nostalgia. Un dolore non spiacevole copre, senza cancellarla, l’antica repulsione.
Ho passato un po’ di tempo a chiedermi perché continuo a guardare e a interessarmi allo sport, il football in particolare, e ne deduco che la passione per lo sport potrebbe essere collegata a un desiderio di appartenenza. Potremmo discutere se sia un’espressione legittima e edificante di questo desiderio, ma il desiderio in sé sembra vitale e genuino. Interessandoci di sport, ci uniamo ad altri nell’interessarci intensamente a qualcosa su cui in sostanza non abbiamo controllo, malgrado i nostri calzini portafortuna. La posta in gioco non è alta sul serio, ma sembra alta, e degna del nostro appassionarci. La nostra impotenza in quanto spettatori passivi è attenuata dal nostro senso di appartenenza, così come dai confortanti riti e rituali cadenzati delle stagioni di gioco e delle dirette televisive. Viviamo di sporadici momenti di gioia e meraviglia, di frequenti delusioni, e, in alcuni casi, di angoscia e terrore. E tutto questo lo viviamo collettivamente, anche quando guardiamo la partita da soli.
Sono restio ad attribuire motivazioni nobili all’atto di guardare lo sport, che dopotutto è più spesso caratterizzato da pigrizia, ubriachezza, briciole di nachos, e da una grave mancanza di equilibrio nella valutazione delle priorità. Ad ogni modo lo farò lo stesso: se interessarsi allo sport ha a che fare con il senso di appartenenza – e se il far parte di un gruppo attenua la nostra impotenza e la delusione che inevitabilmente ne deriva – allora forse è in qualche modo un’espressione, per quanto eccentrica, di brama spirituale.
Quelli tra noi che hanno visto il tremendo infortunio di Theismann, l’hanno visto insieme. Apparteniamo al gruppo di persone che l’ha visto, e quell’azione ci appartiene. Nauseante, estremamente violenta, e nostra. L’appartenenza compensa la brutalità, la trasforma in paradosso e ambivalenza, ovvero ciò a cui tante cose tendono nella mezza età. E nel 1985, a guardare il Monday Night Football sui nostri televisori senza telecomando e a bassa definizione, senza altri schermi su cui girare lo sguardo, appartenevamo a un modo più pieno, nel bene e senza dubbio nel male, a una cultura popolare relativamente monolitica. Non era certo un’epoca d’oro, ma era coerente e condivisa, omogenea, tutte cose che potrebbero spiegare in parte la potenza persistente dell’infortunio di Theismann.
Che cosa si potrebbe dire di un gruppo di uomini che si riunisce ogni anno per rimettere in scena questa azione storica? Hanno raggiunto una certa età, e la loro radicata nostalgia rappresenta un’amplificazione di certi desideri quasi inconsci: smaniano per appartenere di nuovo a un’epoca in cui appartenevano con più fervore a qualcosa, e in cui le squadre e i giocatori appartenevano loro in maniera più profonda. Non sono cattivi. Sono semplicemente religiosi.
© Chris Bachelder, 2016. Tutti i diritti riservati.
Condividi

