Di cosmopolitismo, Storia e ispirazione: Enea Zaramella intervista Rodrigo Hasbún, autore di Andarsene. Il pezzo, uscito come contributo al Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea dell’UNAM è stato poi pubblicato sulla White Review e viene qui riprodotto per gentile concessione dell’autore.
di Enea Zaramella
Rodrigo Hasbún (Cochabamba, 1981) è uno scrittore e sceneggiatore boliviano che ha recentemente attratto l’interesse della critica internazionale. Considerato dalla rivista britannica Granta come uno dei 22 migliori scrittori in lingua spagnola, la sua bibliografia vanta di numerose pubblicazioni, tra cui le raccolte di racconti Cinco (Gente Común, 2006), Los días más felices (Duomo Ediciones, 2011), Cuatro (El Cuervo, 2014), Nueve (Demipage, 2014) e i romanzi El lugar del cuerpo (Alfaguara, 2009) e Los afectos (Random House, 2015), quest’ultimo tradotto in inglese, portoghese, italiano e prossimamente in tedesco, francese, olandese, finlandese, greco e cinese.
Ho avuto l’opportunità e il piacere di dialogare brevemente con Rodrigo Hasbún nei mesi scorsi. Le nostre conversazioni vengono qui riprodotte per i lettori di Sotto il vulcano.
Enea Zaramella: Per un boliviano di origine palestinese che risiede negli Stati Uniti, deterritorializzazione, esilio, geopolitica, cosmopolitismo sono parole chiave che suonano come un luogo comune… ma è vero che dopo aver lasciato un posto, può essere difficile ritornare (ritornare dove, poi?). Qual è la tua esperienza come straniero e/o cittadino del mondo? Qual è la tua idea di casa?
Rodrigo Hasbún: Sono discendente di immigrati e sin dall’infanzia la mia vita è stata caratterizzata da numerosi viaggi; per questo le tue domande mi sono familiari. Sono domande che io stesso mi pongo costantemente. Mi piace lo sguardo esterno dello straniero che con la sua sola presenza riorganizza la mappa. Gli affetti, la fedeltà e il senso di appartenenza non rispondono o sono in relazione a un unico contesto di riferimento – lo straniero c’è e non c’è allo stesso tempo, viene da più luoghi contemporaneamente –, a me piace questo essere al confine e credo sia pure vantaggioso, anche se è vero che alla fine ti lascia un po’ per aria e non sai mai bene dove è casa tua.
Ho avuto l’enorme fortuna di vivere in città molto diverse tra loro (Cochabamba e Barcellona, Ithaca e Santiago, Toronto e Houston), ma non mi considero affatto un cittadino del mondo. Questa espressione non solo non mi piace – chi può aspirare a esserlo e chi no?, a quali condizioni?, da chi viene definito così? – ma essere un cittadino del mondo è quanto di più lontano ci sia dalla mia condizione, quella di uno che viaggia con il passaporto boliviano e ha la faccia da arabo. E mi rendo conto che per alcuni possa essere un problema, ma non per me, mi reputo fortunato se si considera quanto retrograda e brutale continui a essere la realtà di molti immigrati. Malgrado le interminabili pratiche e questioni burocratiche, gli occasionali interrogatori negli aeroporti, faccio comunque parte di quel gruppo di persone che ha la vita facile, e non è costretto a salire su un barcone o attraversare il deserto a piedi per arrivare a destinazione (se è fortunato).
EZ: Mi congratulo per il tuo recente successo, e non sto parlando dei libri, Dottor Hasbún. Per molti la scrittura accademica costituisce un ostacolo alla creatività letteraria. Con le dovute differenze, mi riferisco in entrambi i casi alla scrittura come professione. Che rapporto hai con la scrittura accademica e con quella letteraria? Come riesci a isolare questi due mondi senza che interferiscano?
RH: All’inizio avevo paura che il dottorato finisse per impoverire lo scrittore, che lo rendesse troppo cosciente delle sue azioni. Ma è un timore privo di fondamento; un po’ come un giocatore di calcio che passa il suo tempo libero a studiare la storia di quello sport. Non penso lo renda un giocatore migliore o peggiore quando è in campo con il pallone tra i piedi. Con questo voglio dire che nel mio caso, oltre ai seminari e alle discussioni spesso affascinanti che genera l’ambiente universitario, la scrittura ha continuato a esistere e fluire in quella zona grigia dove non sai quale è la posta in gioco, dove ti chiedi il perché delle tue decisioni, dove le cose più importanti succedono fuori dal tuo controllo. Per certi versi è istintivo.
Come lettore, sono certo di essermi trasformato. Fare il dottorato è stata soprattutto una palestra di lettura: ho imparato a leggere con maggiore attenzione e da diversi punti di vista, a volte anche opposti. Ogni scrittore è il suo primo lettore, ed è grazie a questo tipo di lettura che la scrittura si rinvigorisce, diventa più complessa e solida. Ma d’altra parte, esiste anche il rischio di voler soddisfare nella scrittura certe premesse critiche o teoriche, che poi condizionano un po’ come verrai letto. In ogni caso, bisogna riconoscere che negli ultimi anni decine di scrittori latinoamericani hanno intrapreso programmi di dottorato, ed è certo che, nel bene o nel male, quest’esperienza lascia un segno nella scrittura.
EZ: Mi puoi dire qualcosa in più riguardo i temi principali della tua ricerca accademica?
RH: Con la mia tesi cerco di recuperare il diario intimo, un genere letterario che è stato sottovalutato in America Latina. Partendo dalla lettura di tre diari che apprezzo molto (La tentación del fracaso di Julio Ramón Ribeyro, Ese hombre y otros papeles personales di Rodolfo Walsh e Veneno de escorpión azul di Gonzalo Millán), discuto alcuni dei pregiudizi contenuti nella loro ricezione, dove spesso sono letti più per il loro carattere testimoniale che quello letterario e dove questo tipo di scrittura si considera come esempio di letteratura minore.
Ribeyro ha scritto un diario per quasi quarant’anni, Walsh per quindici e Millán ha dedicato gli ultimi mesi di vita esclusivamente a scrivere il suo. Questo è già di per sé rilevante. Si tratta di una pratica di scrittura indissolubilmente legata all’esperienza del tempo, che si scontra con la quotidianità, contro la fugacità della vita. Mi affascina a mi colpisce l’urgenza che contraddistingue la scrittura del diario, l’idea di poter fissare ciò che è fluido e si muove, di conservare ciò che si ha perduto o che prima o poi si perderà. Sono anche attratto dal diario perché è un genere riluttante alla letteratura come istituzione e al mercato editoriale. Chi scrive un diario volge felicemente le spalle a entrambi.
EZ: Uno dei miei maestri è stato Ricardo Piglia e le tematiche che stai descrivendo mi rimandano alle opere e al pensiero dello scrittore e critico argentino. Da un lato, c’è la lettura. Non che ci si debba far travolgere dalla pedanteria di chi non riesce più a leggere senza una matita in mano (e correggimi se a te non succede), ma, per molti versi, Piglia consiglia di prendere seriamente l’atto di lettura, leggere testando costantemente i limiti del «saper leggere». Dall’altro lato, a proposito della scrittura privata, i diari di Piglia – Los diarios de Emilio Renzi – sono stati recentemente pubblicati con gran risonanza da Anagrama. Qual è il tuo parere?
RH: Che lusso aver avuto Piglia come insegnante! Oltre ad essere uno straordinario scrittore, è stato uno dei migliori critici in lingua spagnola. Io ho iniziato a leggerlo quando avevo diciotto anni e, com’è successo a tanti altri, sono sempre stato molto affascinato dai suoi diari. Ti potrai quindi immaginare la mia felicità quando è uscito il primo volume nel 2015. Oltre a una grande commozione, mi interessa la complessità dell’apparato escogitato da Piglia nel primo volume (e certamente anche nel secondo, che è stato pubblicato l’anno seguente). Si tratta di un diario che, oltre ad essere colmo di vita e caratterizzato da una prosa accattivante, riflette sempre sulla sua condizione, su cos’è o cosa potrebbe essere un diario. Se la fase di maturità del genere diario in America Latina è stata inaugurata da La tentación del fracaso, credo che con i Diarios de Emilio Renzi, venticinque anni dopo, questa fase comincia in qualche modo a chiudersi. Inoltre, sono diari che si somigliano: entrambi sono dettagliati, incredibilmente autoriflessivi e radicalmente editati dagli stessi autori decenni più tardi. Questo fa quasi pensare a una dichiarazione di intenti: un desiderio esplicito di fissare il genere diario e consacrarlo al regno della letteratura.
EZ: Autobiografie, diari, epistolari: tutti generi in cui un autore è obbligato a selezionare certi eventi, a costruire dei personaggi (in questo caso, soprattutto costruire sé stesso come personaggio), e a immaginarsi un lettore. In altre parole, se consideriamo tutti questi elementi come parte di un unico genere narrativo – quello della scrittura intima –, mi sembra che la differenza tra la realtà e la finzione sia molto sottile, o addirittura penso che si tratti di un gesto creativo che pone entrambi concetti sullo stesso piano. Qual è la tua esperienza e quali sono le tue opinioni riguardo quest’aporia (se così la si può chiamare) del genere? Come vedi la relazione tra scrittura intima e Storia o, qual è il tuo concetto di Storia? Pensi, per esempio, che questo genere si presti o sia spesso usato come documento o fonte storica?
RH: Il potenziale documentale di questo tipo di scrittura mi interessa meno della sua dimensione letteraria. Nel campo dell’auto/bio/grafico, si è data troppa importanza al secondo elemento (alla bios, la vita), sorvolando spesso la complessità dell’incontro dei tre. Non è la stessa cosa guardare gli altri e guardare sé stessi: se questo sguardo giunge dalla scrittura, il risultato è ancor più poroso perché entrano in gioco una serie di strategie e resistenze quando una persona cerca di descriversi: quelle cose di sé o del contesto che non possono, non vogliono o non sanno vedere; la loro volontà cosciente o incosciente di raffigurarsi in un determinato modo. Per questo motivo non cerco verità assolute nei diari, nelle biografie o nelle lettere che leggo. Possiamo vedere questi testi come una specie di palcoscenico, dove si è testimoni della costruzione di un’immagine di sé o dove una determinata persona indossa diverse maschere o travestimenti, ma non sono tanto quelle maschere o quei costumi che m’interessano, bensì l’atto stesso di indossarle.
EZ: Andarsene, il tuo ultimo romanzo, si dirige proprio verso questo orizzonte, vero?
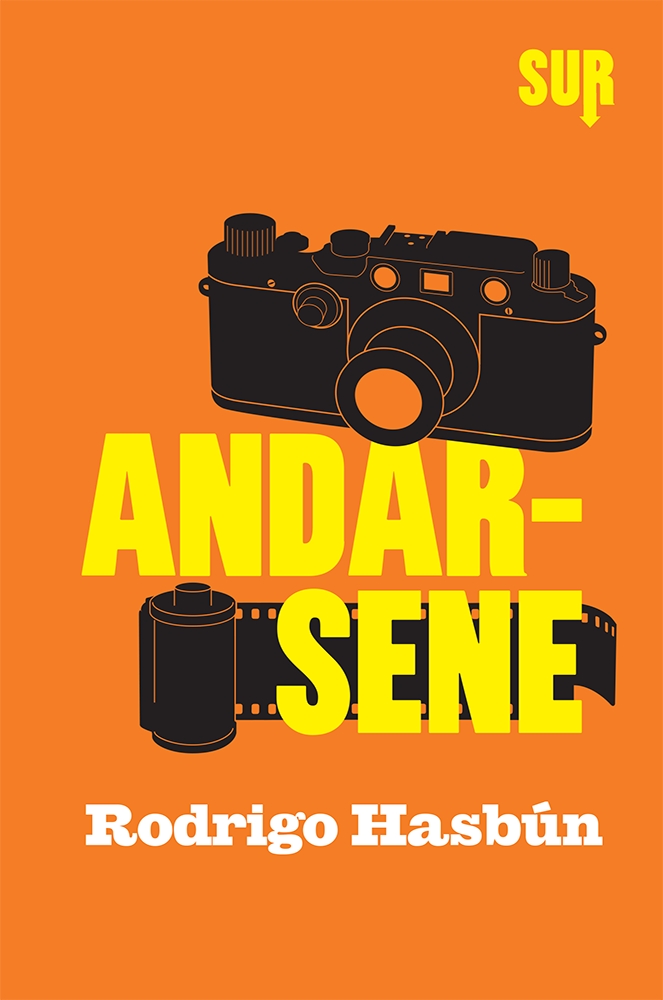
RH: Sì, certo, anche lì i personaggi si provano maschere e costumi diversi: sono sempre alla ricerca di sé e subiscono cambiamenti radicali durante tutto il romanzo. Credo che a tutti noi succeda un po’ la stessa cosa, no? Ci vuole del tempo affinché possiamo diventare noi stessi e accettare quel che siamo o ciò che possiamo essere.
EZ: Come sei riuscito a delineare i tuoi personaggi in Andarsene? Dico «tuoi» ma in verità sono anche «nostri» dato che fanno già parte dei libri di storia. Immagino ti sarai appoggiato a delle ricerche preliminari (documenti, fotografie, scritti personali, ecc.) per, in un certo senso, poterli vedere prima di sentirli parlare. Forse la domanda giusta da porti è: com’è stato il processo, il «processo storico» o letterario, grazie al quale sei riuscito a trasformare qualcosa di nostro in qualcosa di tuo?
RH: Ho visto e letto tutto quello che ho potuto per sei o sette mesi, senza essere pienamente sicuro di ciò che avrei fatto con gli appunti che prendevo e senza sapere verso quale direzione il romanzo s’incamminava. Non c’è molto materiale disponibile sulla famiglia Erlt e credo che questo fattore sia stato decisivo perché ho potuto scrivere con molta più libertà di quanto pensavo fosse possibile all’inizio. È vero che c’erano degli avvenimenti concreti da includere nella storia e ai quali mi potevo aggrappare, ma tutt’attorno predominava la stessa incertezza di sempre. Per esempio, m’interessava entrare nella quotidianità della famiglia, quel tran-tran di cui avevo scoperto ben poco con le mie ricerche. Così ho dovuto immaginarlo completamente, dalle sigarette che condividono Trixi e sua madre fino alla notte del matrimonio di Monika. Per il tipo di scrittore che sono, questi piccoli dettagli sono tanto rilevanti quanto le grandi vicende degli Erlt: dagli elementi che potevano far parte di una biografia agli aspetti più triviali, dalle cose più scontate a quelle meno visibili, dalle avventure e peripezie al viaggio interiore. C’è da dire comunque che la costruzione di questi personaggi è sempre avvenuta attraverso le ambiguità dell’invenzione letteraria. Non voglio convincere nessuno che le loro vite siano state così come le descrivo. Nel migliore dei casi, provo soltanto a convincere i lettori che questo è un modo interessante di scrivere di loro.
EZ: Parlando di maschere e mimetismi, come hai concepito o elaborato la questione di genere, il fatto che siano le voci femminili a narrare il romanzo? È un tipo di sensibilità che proviene dalla scrittura intima?
RH: Tradizionalmente c’è sempre stata una specie di divisione dello spazio in base al genere, no? Penelope, per esempio, aspetta Ulisse a casa mentre lui gira per il mondo. In Andarsene, Aurelia, la madre, rientra un po’ in questo schema. Al contrario, le figlie si ribellano e attraversano più volte il confine nazionale e rompono gli schemi del cosiddetto ruolo «femminile». Entrano ed escono come vogliono e non condividono la visione che ha il padre delle cose, le storie che racconta. Seguendo questa logica, il romanzo è narrato attraverso i punti di vista delle ragazze e non tramite quello di Hans.
E poi, come hai osservato, il tema dell’intimità m’interessa molto, ma non lo penso in termini di genere, bensì di prossimità a ciò che si narra. Voglio stare vicino ai miei personaggi, comprendere i loro dilemmi e frustrazioni, le loro paure, i punti deboli. Voglio sapere di che pasta sono fatti.
EZ: Ancora congratulazioni, Andarsene è appena uscito o uscirà a breve in diversi paesi. Come hai vissuto il processo di traduzione? Ti fai coinvolgere molto? Quali sono le «libertà» che lasci alle traduttrici e traduttori che esprimono le tue parole in altre culture e contesti linguistici?
RH: I traduttori sono gli eroi e le eroine invisibili della letteratura perché sono loro che in verità la mantengono in vita. Credo che potremmo pure smettere di scrivere libri (ce ne sono già tanti, e ne conosciamo talmente pochi), fin quando continueremo a tradurre. Per quanto riguarda il processo in sé, nel mio caso lo scrittore diventa un copilota: cedo il volante di quella macchina che mi ha dato tanti grattacapi e mi siedo nel lato del passeggero. Chi sceglie le parole, chi lotta con il linguaggio frase dopo frase è il traduttore/traduttrice e il libro che ne esce è tanto suo come dello scrittore. Io sono un ossessivo cronico e riuscirei a sprecare giornate intere a togliere e aggiungere e togliere ancora una sola parola. Ho fatto fatica a diventare questa sorta di copilota della traduzione, uno che conosce bene la strada e può aiutare a non perdersi. Del resto, a parte lo spagnolo conosco soltanto l’inglese, l’unica traduzione che ho potuto leggere.
EZ: Per concludere questa breve conversazione e con la speranza di poterla continuare, in vista di altre tue pubblicazioni, volevo sapere se stai lavorando a qualche altro progetto. Cosa c’è nella lista delle cose da fare sulla tua scrivania?
RH: Quest’ultimo anno l’ho passato quasi esclusivamente a lavorare alla tesi. Non appena finita, qualche mese fa, ho subito iniziato a scrivere qualcosa di nuovo. Non so ancora cosa sarà, ma sono molto preso e vedo come certe cose prendono forma lentamente e trovano il loro spazio. Durante la fase di scrittura, succede qualcosa di difficile da spiegare. Un’antenna si accende e tutto ciò che ti circonda comincia a mandarti dei segnali. Una storiella del dj alla radio, qualcosa che vedi per strada, una barzelletta che ti racconta tua madre per telefono: improvvisamente non c’è niente che non riesca ad influenzare in qualche modo quello che stai scrivendo. È meraviglioso… e spero soltanto che questo duri abbastanza da poter uscirne con un nuovo libro sotto braccio!
© Enea Zaramella, 2017. Tutti i diritti riservati.
Condividi

