Da Whitehead a Beatty, un en plein nei più importanti premi in lingua inglese. Ma non è solo la risposta al presidente reazionario. Viaggio in una comunità letteraria tutta da scoprire.
L’articolo è stato pubblicato originariamente dal Venerdì di Repubblica e viene qui riprodotto per gentile concessione dell’autore e della testata.
di Luca Briasco
 Un fenomeno nuovo ha attraversato la scena letteraria e culturale americana a cavallo tra il 2016 e il 2017. Per la prima volta nella storia, i tre principali premi letterari di lingua inglese sono stati aggiudicati a romanzi di autori afroamericani. The Underground Railroad, di Colson Whitehead – da poco in Italia per le Edizioni Sur, con il titolo fedele La ferrovia sotterranea e la splendida traduzione di Martina Testa – ha ottenuto a distanza di pochi mesi National Book Award e Pulitzer per la narrativa (accoppiata riuscita in passato solo ad altri sei autori, tra cui la Alice Walker di Il colore viola, caposaldo della letteratura nera al femminile), mentre The Sellout di Paul Beatty (uscito in Italia da Fazi con il titolo Lo schiavista) è stato insignito del prestigioso Man Booker Prize, che premia il miglior romanzo di lingua inglese e che solo di recente ha aperto le porte, oltre che ad autori britannici e del Commonwealth, anche a opere provenienti dagli Stati Uniti.
Un fenomeno nuovo ha attraversato la scena letteraria e culturale americana a cavallo tra il 2016 e il 2017. Per la prima volta nella storia, i tre principali premi letterari di lingua inglese sono stati aggiudicati a romanzi di autori afroamericani. The Underground Railroad, di Colson Whitehead – da poco in Italia per le Edizioni Sur, con il titolo fedele La ferrovia sotterranea e la splendida traduzione di Martina Testa – ha ottenuto a distanza di pochi mesi National Book Award e Pulitzer per la narrativa (accoppiata riuscita in passato solo ad altri sei autori, tra cui la Alice Walker di Il colore viola, caposaldo della letteratura nera al femminile), mentre The Sellout di Paul Beatty (uscito in Italia da Fazi con il titolo Lo schiavista) è stato insignito del prestigioso Man Booker Prize, che premia il miglior romanzo di lingua inglese e che solo di recente ha aperto le porte, oltre che ad autori britannici e del Commonwealth, anche a opere provenienti dagli Stati Uniti.
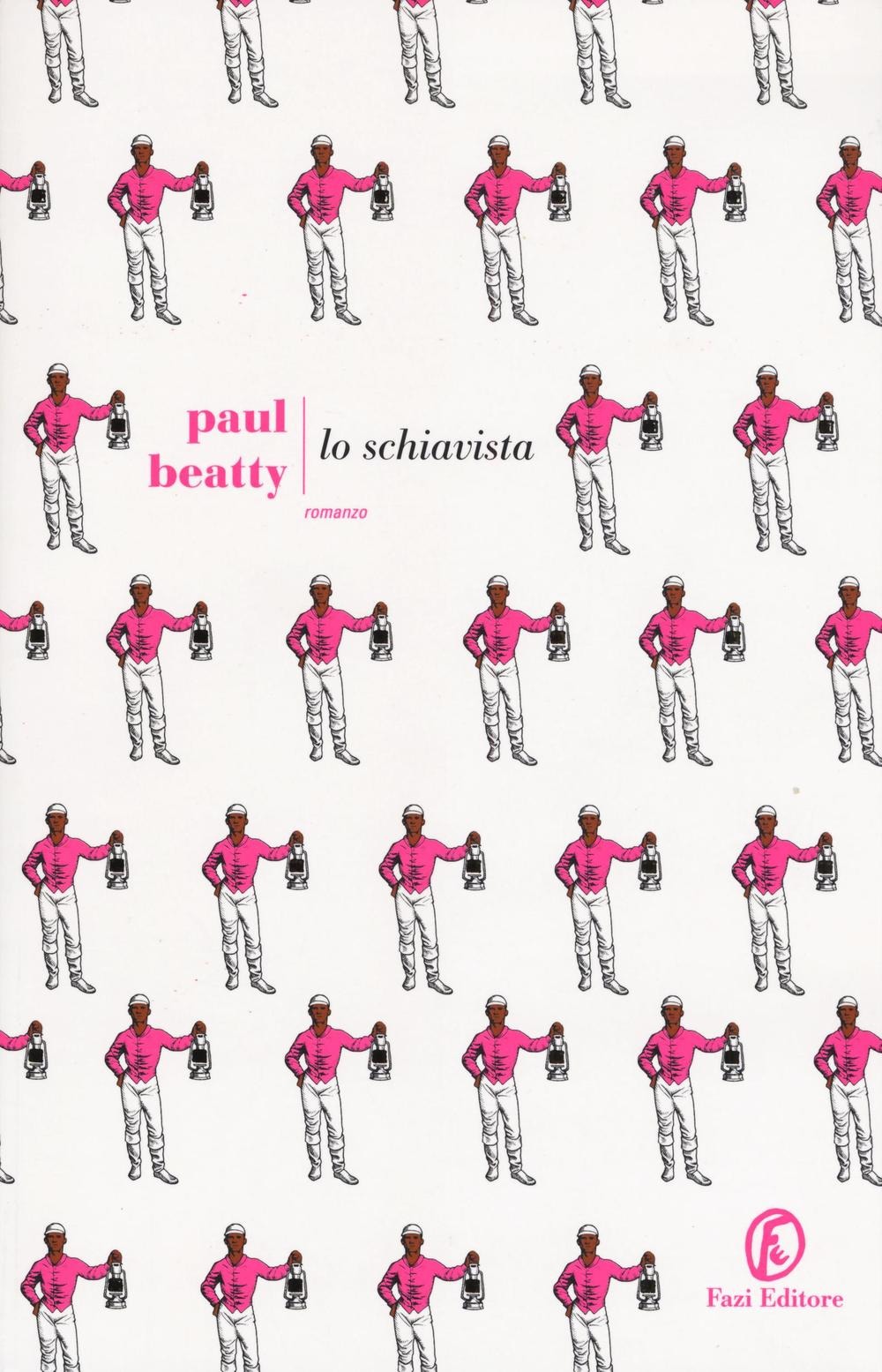 Dietro questa improvvisa cornucopia di premi è possibile che, almeno in parte, si nasconda una reazione all’esito delle ultime elezioni presidenziali e all’avvento di Donald Trump: un modo, dunque, con il quale una comunità letteraria tradizionalmente liberale ribadisce le ragioni della propria radicale difformità da ogni recrudescenza razzista o suprematista. Oltre al diluvio di tweet e di commenti con il quale scrittori di grandissimo calibro, da Stephen King a Joyce Carol Oates, accompagnano le gesta del nuovo presidente, questa reazione ha avuto la sua riprova più plastica in occasione della notte degli Oscar, con l ’annuncio errato della vittoria, come miglior film, di un musical rétro e in fondo rassicurante come La La Land, e il trionfo finale di Moonlight, ritratto tutto afroamericano di un’adolescenza segnata da disagi, violenza e droghe.
Dietro questa improvvisa cornucopia di premi è possibile che, almeno in parte, si nasconda una reazione all’esito delle ultime elezioni presidenziali e all’avvento di Donald Trump: un modo, dunque, con il quale una comunità letteraria tradizionalmente liberale ribadisce le ragioni della propria radicale difformità da ogni recrudescenza razzista o suprematista. Oltre al diluvio di tweet e di commenti con il quale scrittori di grandissimo calibro, da Stephen King a Joyce Carol Oates, accompagnano le gesta del nuovo presidente, questa reazione ha avuto la sua riprova più plastica in occasione della notte degli Oscar, con l ’annuncio errato della vittoria, come miglior film, di un musical rétro e in fondo rassicurante come La La Land, e il trionfo finale di Moonlight, ritratto tutto afroamericano di un’adolescenza segnata da disagi, violenza e droghe.
Ridurre il trionfo di Whitehead e Beatty al frutto di un semplice rigurgito liberale della reazione contro una cultura populista e brutalmente semplificatoria non renderebbe però merito a una generazione di scrittori che include, oltre ai due premiati, un altro autore di grande inventiva come Percival Everett, e che ha saputo costruirsi uno spazio originale e nuovo tanto all’interno della tradizione afroamericana quanto più in generale nel quadro della narrativa statunitense. Che abbiano superato i sessant’anni come Everett o si avvicinino ora ai cinquanta come Whitehead, gli autori in questione sono accomunati da un approccio libero e onnivoro alle forme del racconto, che recupera in una chiave molto più fruibile e accattivante lo sperimentalismo postmoderno e non esita a giocare con i generi letterari di massa, smontandoli e riscrivendone le regole.
Un approccio, questo, in profonda controtendenza rispetto a una tradizione letteraria afroamericana che, da Richard Wright a James Baldwin, aveva sistematicamente pagato dazio alla regola non scritta secondo la quale, per denunciare il retaggio di razzismo e violenza insito nella società americana, fosse imprescindibile ricorrere a narrazioni sostanzialmente realistiche o tutt’al più, come nel caso di L’uomo invisibile di Ralph Ellison, virate e deformate in chiave espressionista. Un’eredità pesante che nella grande stagione di protesta degli anni Sessanta, inaugurata da un saggio fondamentale come La prossima volta. Il fuoco di Baldwin, del 1963, fu raccolta dalle autobiografe di Malcolm X e di leader della protesta nera come Eldridge Cleaver, George Jackson e Angela Davis, mentre la narrativa di invenzione, dominata dal postmoderno, rimaneva in massima parte bianca, anglosassone o ebraica, con l’unica eccezione del sulfureo Ishmael Reed, capace di raccontare la complessità e la stratifcazione della cultura nera in Mumbo Jumbo (sua unica opera tradotta in italiano), ma anche il retaggio della schiavitù in quel Flight to Canada che, per alcuni aspetti, può essere considerato un antesignano di La ferrovia sotterranea.
In un romanzo godibile quanto complesso come Cancellazione, Percival Everett ha saputo raccontare, utilizzando i toni ficcanti della satira, il dilemma con il quale è chiamato a fare i conti oggi lo scrittore maschio e afroamericano (diverso è evidentemente il caso della narrativa femminile, che negli anni Ottanta, e in opere come Amatissima di Toni Morrison o Il colore viola di Alice Walker, era riuscita a rileggere e rinverdire la tradizione nera attraverso una geniale ed efficacissima mediazione tra racconto orale e grande letteratura dei sud, Faulkner in testa). Il protagonista del libro di Everett, uno scrittore e professore universitario che si chiama Thelonious «Monk» Ellison (un nome che è tutto un programma), stanco di sentirsi accusare perché troppo «poco afroamericano», decide di dedicarsi a una riscrittura in chiave satirica di Native Son (Paura in italiano) il capolavoro realistico di Richard Wright, e rimane sgomento nello scoprire che tutti lo hanno preso tremendamente sul serio e che il suo nuovo libro si prepara a mietere i successi che, in passato, gli sono sempre stati negati.
 Con Lo schiavista (e le altre opere di Beatty, primo fra tutti il suo esordio, Il blues del ragazzo bianco, che esce in questi giorni da Fazi) e con La ferrovia sotterranea, lo sperimentalismo, la volontà di costruire strutture complesse, di mescidare realismo, iperrealismo, fantastico e ucronia, raggiungono forse il risultato più alto. E nel caso di Whitehead, alla indubbia qualità dell’opera – se non la migliore in assoluto, certamente la più limpida e risolta della sua non brevissima carriera – è corrisposto un clamoroso successo anche di pubblico, oltre al plauso di recensori, intellettuali e figure del peso di Barack Obama. Non c’è da stupirsene: nella storia di Cora, schiava nera di terza generazione – che di fronte agli abusi cui, nella piantagione, viene sottoposta tanto dai padroni bianchi quanto dai maschi della sua stessa razza, decide di tentare la fuga e di entrare in contatto con l’Underground Railroad, la rete clandestina organizzata dagli abolizionisti che, nella prima metà del diciannovesimo secolo, riuscì a far fuggire decine di migliaia di schiavi consentendo loro di raggiungere gli Stati del nord o direttamente la frontiera canadese – converge un’impressionante quantità di tradizioni, a partire dalle slave narratives dell’Ottocento, passando per La capanna dello zio Tom e arrivando fino a Toni Morrison. Ma Whitehead introduce una variante decisiva, e a suo modo geniale: letteralizza il concetto di «ferrovia sotterranea» e immagina una rete di binari e stazioni di scambio che scorre sotto la superficie insanguinata dell’America razzista. La fuga di Cora, che attraversa gli Stati del Sud inseguita da Ridgeway, un brutale cacciatore di schiavi che ricorda vagamente Chigurh, il killer di Non è un paese per vecchi, la porta a fare i conti con uno scenario fosco e brutale, una sorta di inferno dantesco nel quale ci vediamo scorrere davanti tutti gli or- rori perpetrati, nell’Ottocento e non solo, nel nome della razza.
Con Lo schiavista (e le altre opere di Beatty, primo fra tutti il suo esordio, Il blues del ragazzo bianco, che esce in questi giorni da Fazi) e con La ferrovia sotterranea, lo sperimentalismo, la volontà di costruire strutture complesse, di mescidare realismo, iperrealismo, fantastico e ucronia, raggiungono forse il risultato più alto. E nel caso di Whitehead, alla indubbia qualità dell’opera – se non la migliore in assoluto, certamente la più limpida e risolta della sua non brevissima carriera – è corrisposto un clamoroso successo anche di pubblico, oltre al plauso di recensori, intellettuali e figure del peso di Barack Obama. Non c’è da stupirsene: nella storia di Cora, schiava nera di terza generazione – che di fronte agli abusi cui, nella piantagione, viene sottoposta tanto dai padroni bianchi quanto dai maschi della sua stessa razza, decide di tentare la fuga e di entrare in contatto con l’Underground Railroad, la rete clandestina organizzata dagli abolizionisti che, nella prima metà del diciannovesimo secolo, riuscì a far fuggire decine di migliaia di schiavi consentendo loro di raggiungere gli Stati del nord o direttamente la frontiera canadese – converge un’impressionante quantità di tradizioni, a partire dalle slave narratives dell’Ottocento, passando per La capanna dello zio Tom e arrivando fino a Toni Morrison. Ma Whitehead introduce una variante decisiva, e a suo modo geniale: letteralizza il concetto di «ferrovia sotterranea» e immagina una rete di binari e stazioni di scambio che scorre sotto la superficie insanguinata dell’America razzista. La fuga di Cora, che attraversa gli Stati del Sud inseguita da Ridgeway, un brutale cacciatore di schiavi che ricorda vagamente Chigurh, il killer di Non è un paese per vecchi, la porta a fare i conti con uno scenario fosco e brutale, una sorta di inferno dantesco nel quale ci vediamo scorrere davanti tutti gli or- rori perpetrati, nell’Ottocento e non solo, nel nome della razza.
Dalla fantascienza filosofica del suo fulminante esordio, L’intuizionista, alla formidabile saga carnevalesca di John Henry Festival; dal romanzo di formazione vagamente rétro di Sag Harbor all’epica zombie di Zona Uno, Whitehead aveva costruito un percorso personalissimo, insofferente agli schemi e irrequieto, nel quale l’unica vera riconoscibilità derivava, per paradosso, dal fatto che ogni nuovo romanzo rappresentasse un netto scarto rispetto al precedente. Spaziando tra grande storia di avventura e distopia, delirio gotico e affresco sociale, La ferrovia sotterranea ha segnato una consacrazione a lungo attesa, la sintesi di un viaggio creativo e, forse, un punto di svolta per la narrativa afroamericana.
© Luca Briasco, 2017. Tutti i diritti riservati.
Condividi

