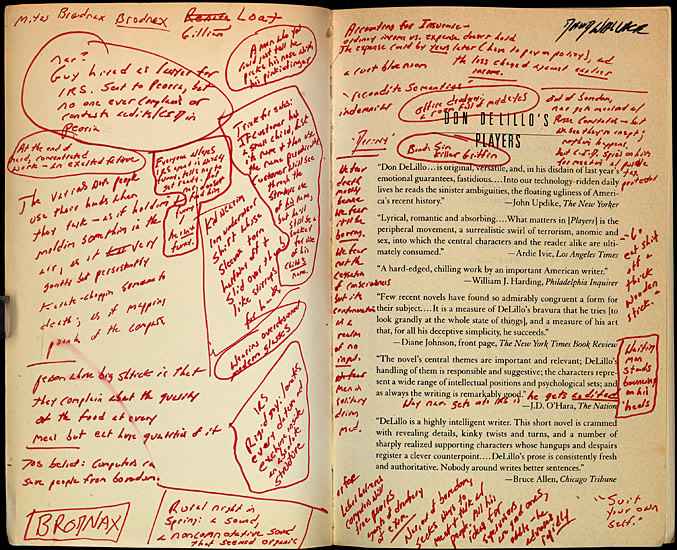Il linguaggio dei cosiddetti «blurb» editoriali può veicolare a volte anche giudizi sinceri e serie riflessioni letterarie. Ce lo spiega Lucas Thompson, attraverso una disamina dei blurb scritti da David Foster Wallace nell’arco della sua carriera. Il saggio è apparso originariamente sulla Los Angeles Review of Books; ringraziamo l’autore.
di Lucas Thompson
traduzione di Martina Testa
Inutile girarci intorno: i blurb sono un aspetto della cultura editoriale che gode di pessima fama. Per molti, i giudizi firmati da nomi noti che compaiono in bella mostra sulle copertine dei libri andrebbero totalmente ignorati, a prescindere dall’autore, perché non hanno nessun vero rapporto con l’opera che in teoria descrivono. In parte questo cinismo deriva dall’infima qualità di molti blurb, che invariabilmente sembrano essere stati sfornati in fretta e alla bell’e meglio, o attribuiscono al libro qualità di gran lunga esagerate. In fondo, c’è un limite al numero di nuovi romanzi che si possono definire «straordinariamente avvincenti» o «incredibilmente originali» prima che queste espressioni comincino a perdere qualunque significato. Lo scetticismo dei lettori nei confronti dei blurb è anche dovuto ai sospetti sull’onestà – o meglio, la scarsa onestà – di questi giudizi. Non è certo un segreto che le case editrici spesso commissionino espressamente dei blurb nel tentativo di aumentare le vendite, facendosi restituire qualche favore e blandendo gli scrittori di alto profilo nella speranza di ottenere lodi sperticate del libro in uscita. Questa insincerità percepita è forse l’aspetto più fastidioso di molti blurb, tanto che un’autorità del calibro di George Orwell, nel suo splendido saggio «In difesa del romanzo», arrivava a caratterizzarli come «disgustose idiozie».
Non sorprende, quindi, che anche David Foster Wallace fosse molto cinico rispetto al fenomeno dei blurb. Durante un reading, nel 2004, quando gli venne fatta una domanda sui blurb che compaiono sulle copertine dei suoi libri, Wallace coniò l’utile termine blurbspeak, che definì come
un particolare sotto-dialetto dell’inglese fatto in parte di iperboli, e in parte di espressioni che suonano molto bene e sono molto convincenti dal punto di vista pubblicitario, ma che se uno ci pensa bene sono letteralmente senza senso.
Nonostante si fosse poi affrettato a puntualizzare che le espressioni vaghe ma positive sono ovviamente «di gran lunga preferibili alle espressioni senza senso ma feroci», la critica di Wallace va dritta al cuore di ciò che spesso c’è di cattivo gusto nei blurb. Il suo accenno alla cultura del marketing è rivelatorio, dato che i «consumatori» esperti di prodotti letterari tendono a trattare i blurb come messaggi pubblicitari leggermente irritanti.
Eppure, nonostante tutto questo giustificato cinismo, i blurb funzionano ancora. C’è un buon motivo per cui gli editori passano tanto tempo a fare moine agli autori famosi per convincerli a comporre quelle frasi barocche e adulatorie, perché per la gran parte di noi c’è ancora un che di persuasivo nel vedere la raccomandazione di uno scrittore che amiamo sulla copertina di un libro appena uscito. Può darsi che alla base ci sia una forma inconscia di eccezionalismo: pur sapendo che il genere del blurb, nel suo complesso, è irrimediabilmente inflazionato e corrotto, scegliamo di credere che il particolare giudizio che stiamo leggendo sia sincero. Di fatto, credo che molto spesso diamo per scontato che, nonostante nel mondo editoriale abbondino il clientelismo e gli scambi di favori, esista ancora un margine di libertà in virtù del quale un autore può davvero sfruttare l’occasione di un blurb in buona fede, per segnalare ai suoi fan una nuova uscita.
O quantomeno, è in questi termini che mi piace pensare ai blurb firmati dagli scrittori che ammiro. Nel caso di David Foster Wallace, che malgrado il suo profondo scetticismo al riguardo ne ha comunque scritti parecchi, ci sono molti libri che forse non avrei mai preso in mano senza la sua raccomandazione. Ad esempio, il brillante e bizzarro esordio di Dan Josefson, That’s Not a Feeling, del 2012. Il giudizio di Wallace su questo romanzo («Dan Josefson è uno scrittore sbalorditivamente promettente, e That’s Not a Feeling è un esordio coraggioso, divertente, caustico e di grande intelligenza») era così significativo che la Soho Press lo usò sia in prima che in quarta di copertina, e addirittura pubblicò in appendice un’intervista allo scrittore Tom Bissell in cui si spiegava l’origine di quel blurb. Il racconto di Bissell descrive ciò che Wallace trovava affascinante nel romanzo, ma rivela anche che Wallace aveva una teoria seria sulla funzione dei blurb. Bissell riferisce che, nel 2008, i due avevano fatto «una lunga conversazione sulla funzione dei blurb, e sul motivo della loro importanza», rammaricandosi di non aver, all’epoca, preso appunti.
That’s Not a Feeling mi è piaciuto molto per i suoi meriti intrinseci, ma è stata anche bella l’esperienza di leggere il libro con gli occhi di Wallace, pensando al tipo di elementi che l’avrebbero potuto attrarre, e alla maggiore o minore coincidenza con la sua estetica letteraria. Perciò mi è sempre sembrato strano che dei molti blurb composti da Wallace non si parli mai. Evidentemente gli studiosi non li ritengono degni di esame critico – nonostante l’importante lavoro fatto da Gérard Genette sui «paratesti» e «peritesti» letterari a fine anni Ottanta – e la maggioranza dei lettori comuni o non conoscono gli endorsement scritti da Wallace, oppure condividono il generale scetticismo di cui si parlava prima e quindi non li prendono sul serio.
Ma io credo che ci siano tre ragioni fondamentali per cui vale la pena di prestare attenzione a questi blurb. Tanto per cominciare, forniscono una testimonianza indiretta dell’evoluzione delle idee di Wallace sullo scopo della letteratura, e vanno a formare una storia parallela rispetto alle dichiarazioni di poetica che esprimeva altrove. Letti con attenzione, i suoi blurb rivelano interessanti punti di contatto con queste dichiarazioni più generali, oltre a evidenziare certe particolari qualità che apprezzava nella narrativa. Indicano inoltre la familiarità di Wallace con una sorprendente e spesso inaspettata gamma di testi, dimostrando l’ampiezza dei suoi interessi intellettuali. Infine, i blurb in sé sono composti nella maggior parte dei casi di frasi ben cesellate ed eleganti, che potrebbero addirittura rappresentare un’estrema propaggine dell’opera pubblicata – sia pur mai raccolta in volume – di Wallace. Benché negli ultimi anni molti degli articoli sparsi, dei materiali didattici e degli altri scritti di Wallace siano stati pubblicati, la ventina di blurb che produsse nel corso della sua carriera sono stati, secondo me, ingiustamente trascurati. La rassegna che segue invita ad analizzarli più da vicino.
***
Oltre al caso di Josefson, Wallace ha scritto numerosi blurb per altri giovani autori di romanzi e racconti la cui carriera avrebbe potuto fare un salto di qualità grazie a una raccomandazione di alto profilo. In molti dei blurb che rientrano in questa categoria appare evidente la sua generosità verso tali colleghi. Nel 1989, per esempio, elogiò il primo romanzo della ventottenne A.M. Homes, Jack, descrivendolo come «[un] romanzo commovente, e una gran boccata d’aria fresca. Jack è un essere umano così coinvolgente, così affascinante, che è un piacere credere in lui». In questa fase della sua carriera, due anni dopo la pubblicazione di La scopa del sistema, la credibilità dei personaggi letterari stava diventando un tema più centrale per Wallace, che si allontanava pian piano dalla sua scrittura inizialmente basata sulle tipiche trovate a effetto del postmodernismo, e cominciava a ridare valore a elementi narrativi più tradizionali. È difficile immaginare che il Wallace implacabilmente cerebrale di qualche anno prima avrebbe lodato un romanzo per il fatto di avere un protagonista accattivante o «affascinante», mentre nelle sue opere successive avrebbe dato la priorità proprio a quegli aspetti. In seguito, significativamente, confessò a David Lipsky di non essersi reso conto, nel periodo in cui lavorava all’editing della Scopa, che il punto di forza del romanzo non stava nel tema della filosofia esoterica ma nel suo ritratto di Lenore Beadsman, l’unico personaggio «che sembra almeno un po’ attraente e viv[o]».
Ma solo un anno dopo, Wallace esaltava Mio cugino, il mio gastroenterologo (1990) di Mark Leyner, in un blurb che mostra la sua diffidenza verso le forme convenzionali del realismo letterario. Secondo Wallace, il libro di Leyner
farà piazza pulita delle vostre aspettative riguardo alla letteratura di ultimo modello. Tenuto insieme da ossessioni troppo bizzarre per non essere reali, questo magnifico riassetto dell’arredo mentale del nostro secolo testimonia l’arrivo di un nuovo talento del livello di Burroughs/Coover/Acker.
L’entusiastico elogio della raccolta è sorprendente, perché è ben noto che Wallace ritrattò tale giudizio nel suo saggio «E Unibus Pluram», del 1993, in cui sosteneva che l’unico obiettivo di Leyner, in quel libro, era in fin dei conti di una superficialità deprimente: «far sì che il lettore provi piacere e vada avanti a leggere». Ma l’euforia iniziale è rivelatoria, perché fotografa Wallace nel momento in cui si guarda intorno alla ricerca di una nuova direzione estetica. (È anche significativo che Wallace abbia preso le distanze da Kathy Acker, in una recensione di Portrait of an Eye pubblicata più o meno nello stesso periodo.) Mentre l’approccio narrativo di Leyner gli era sembrato in un primo momento una via d’uscita dalla casa stregata del postmoderno, una soluzione all’apparente esaurimento delle forme artistiche, Wallace finì per ritenere che quell’approccio conducesse all’ennesimo vicolo cieco.
È altrettanto sorprendente scoprire che nel 1994 Wallace scrisse un blurb per Acid House, una raccolta di racconti di Irvine Welsh, che all’epoca stava cercando di affermarsi negli Stati Uniti sulla scorta del successo di Trainspotting. Wallace chiamò Welsh the real thing, il nonplusultra, dichiarando che la raccolta conteneva «un meraviglioso miscuglio di nichilismo e sofferenza romantica, realismo accuratissimo (specie nel dialetto e nel tono) e universalità quasi archetipica». L’enfasi di Wallace sulla questione del dialetto è del tutto coerente con il tipo di voci su cui all’epoca stava lavorando a sua volta (per esempio, l’uso dell’Ebonics, dello Spanglish e dell’irlandese in Infinite Jest). Ma il blurb dimostra anche una strana incoerenza nell’atteggiamento verso il nichilismo letterario, dato che più o meno nello stesso periodo Wallace stava criticando Bret Easton Ellis proprio per la stessa estetica. Bisogna presumere che gli altri pregi della narrativa di Welsh – come la sua attenzione verso le figure di outsider che destabilizzano le ideologie dominanti – abbiano reso più accettabile agli occhi di Wallace il suo trattamento della disperazione nichilistica. (O forse la verità è solo che era più facile elogiare un suo contemporaneo britannico che un suo rivale americano.)
Nella seconda metà degli anni Novanta, dopo la pubblicazione di Infinite Jest, la poetica di Wallace si era ormai definita con più precisione. I blurb che scrisse per Ken Kalfus e Susan Daitch riecheggiano le sue affermazioni sulla funzione della letteratura, e al tempo stesso alludono a quelli che considerava i suoi principali difetti di narratore. Ecco il blurb di Wallace per Storytown della Daitch, del 1996:
Questi racconti raffinati e toccanti parlano della morte del significato, di persone che cercano di decodificare il mare di segni in cui fluttuano e affogano, senza riuscirci. Nel loro fallimento c’è la loro vittoria: ci provano – e allora queste sono anche storie di coraggio, la più tragica delle virtù. Una raccolta importante, di una delle scrittrici più intelligenti e attente che abbiamo oggi negli Stati Uniti.
Ed ecco quello, altrettanto corposo, che scrisse per Sete, la raccolta di racconti con cui Ken Kalfus esordì nel 1998:
Un libro da mettere in mano a chi rompe le palle lagnandosi del futuro poco promettente della narrativa americana. È la raccolta di racconti più emozionante dopo Bengodi di George Saunders; e Ken Kalfus è uno scrittore importante, in tutti i sensi del termine. Ci sono scrittori spiritosi e moderni, ci sono scrittori astuti, tecnicamente innovativi, e ci sono scrittori saggi, commoventi e profondi. Kalfus è tutte queste cose insieme, e i racconti di Sete riescono contemporaneamente a divertire, impressionare, provocare e redimere. Hip hip, urrà!
Quest’ultimo è uno dei blurb più lunghi di Wallace, e ancora una volta dimostra il suo entusiasmo per l’opera di uno scrittore a inizio carriera. Ma offre anche un giudizio indiretto sulla sua stessa scrittura: non è difficile intuire un’autovalutazione da parte di Wallace in base alla quale la sua opera bastava a fargli meritare l’inclusione nella prima categoria di scrittori, ma non bastava a dargli stabilmente un posto nella seconda. In questa fase della sua carriera, Wallace stava senz’altro prendendo le distanze dal costante ricorso alle acrobazie cerebrali che l’aveva caratterizzato in precedenza, ma cercava ancora il modo di combinare le tecniche postmoderne con un impatto emotivo efficace. Per Wallace, Sete riusciva a fare esattamente questo, e anche la raccolta sperimentale della Daitch – nel suo tentativo di fondere «virtù» ed emozioni autentiche con un trattamento più astratto dell’esigenza di «decodificare il mare di segni» che ci circonda – era in linea con il suo progetto artistico riveduto e corretto.
Con il passaggio alla narrativa del ventunesimo secolo, Wallace cominciò a scrivere blurb per autori di più alto profilo. Nel 2001 si profuse in un encomio lungo un’intera cartella per L’opera struggente di un formidabile genio di Dave Eggers, in cui lodava la capacità del romanzo di essere «tremendamente, tremendamente commovente, senza mai risultare melenso o forzato», nonché la sua «disponibilità a rischiare» l’apparente «caduta di tono o sentimentalismo». Nel blurb, Wallace ammira inoltra la bravura di Eggers nello scrivere «arie di cordoglio» affiancandole a «brevi sketch postmoderni», e rivela candidamente la propria paura di apparire stucchevole o sentimentale.
Ma l’aspetto che colpisce di più in quel lungo endorsement è che è scritto come una lettera privata a Eggers, al quale Wallace si rivolge personalmente, parlando della «tua disponibilità […]» e accennando a punti del libro in cui «ti lasci andare». Questo fa pensare che Wallace vedesse i blurb non solo come un’occasione per informare i potenziali lettori del valore del libro, ma come un’opportunità per dialogare con l’autore. Solo poche edizioni del romanzo furono stampate con il blurb intero, le altre usarono una versione molto compressa dell’elogio di Wallace: «Per me questa cosa è decollata fin dalle prime pagine e non si è più fermata. È un libro spietato».
Wallace diede un parere simile sulle Correzioni di Jonathan Franzen, descrivendo il romanzo come un libro «divertente e profondamente triste, pieno di compassione e spietato» che «dimostra quanto possono essere variegati e profondi i piaceri che sa offrire la grande letteratura». Fra parentesi, «spietato» non sembra esattamente un’altissima forma di elogio, ma è chiaro che Wallace pensava che i romanzi di vero spessore letterario dovessero essere emotivamente disarmanti oltre che stimolanti dal punto di vista intellettuale. Sponsorizzò anche il romanzo storico Tourmaline, di Joanna Scott, del 2002 (definendo l’autrice «la crème de la crème della nostra generazione»), e nel 2001 scrisse un blurb illuminante per Dogwalker di Arthur Bradford:
Leggere questo libro è come poter andare a pranzo con la parte di noi che di notte sogna […] Racconti che sono teneri, suggestivi, evocativi, generosi, e veri come può essere vero solo ciò che è molto strano.
Questa elegante sinossi della raccolta di Bradford combacia con le idee sull’espressionismo surrealista che Wallace aveva esposto altrove, ad esempio nel suo pezzo del 1996 su David Lynch – il quale, raccontava, lo aveva portato a capire che «essere un surrealista […] non ti esentava affatto da certe responsabilità [del realismo]. Anzi, le aumentava» – e nel suo intervento al PEN su Kafka. Di fatto, Wallace avrebbe potuto benissimo descrivere la narrativa di Kafka negli stessi termini. Questo blurb si concilia perfettamente con la caratterizzazione dei racconti di Kafka come «eroicamente sani» malgrado la loro grottesca e onirica stramberia.
Più o meno nello stesso periodo Wallace stava anche difendendo scrittori più anziani o più sperimentali che considerava ingiustamente trascurati, operazione del tutto in sintonia con il suo articolo di Salon del 1999 su quelli che definiva «romanzi statunitensi tragicamente sottovalutati > 1960». Ad esempio, scrisse un importante blurb per la ristampa, uscita per Norton nel 1999, di Quello che rimane di Paula Fox («Un’imprescindibile pietra miliare del realismo del dopoguerra […] un esercizio costante di prosa così lucida e cesellata che non sembra tanto scritta quanto scolpita nella pietra»), che fu messo in grande evidenza sulla quarta di copertina di quell’edizione, in corpo maggiore rispetto agli altri blurb. A scrivere l’introduzione al volume fu proprio Franzen, che in precedenza aveva preso spunto dal romanzo breve della Fox per parlare del ruolo sempre meno rilevante della narrativa nel suo saggio del 1996, «Perché scrivere romanzi?» Ma pur nella sua concisione, il giudizio di Wallace è abbastanza significativo per la distanza che dimostra dalla lettura di Franzen. Mentre quest’ultimo considerava Quello che rimane un perfetto esempio di letteratura impegnata, trattandolo come un modello «estremamente pertinente» per la narrativa che riflette la realtà sociale, a Wallace importava sottolineare l’insolita estetica del romanzo, soffermandosi sulla prosa «lucida e cesellata» della Fox, che gli sembrava avere un tale peso da essere stata incisa sulla pagina. Inoltre, mentre secondo Franzen Quello che rimane offriva un esempio per chi volesse ridare rilevanza alla letteratura in un’epoca di saturazione mediatica, Wallace collocava il romanzo decisamente nel passato, come incarnazione di una particolare versione del «realismo del dopoguerra» che non si poteva più proporre come approccio artistico plausibile.
In questo periodo più tardo, escono anche dei blurb che sono in maniera abbastanza evidente frutto di accordi reciproci, o semplici favori agli amici. Wallace ne scrisse uno, ad esempio, per Mark Costello, con cui aveva collaborato a Il rap spiegato ai bianchi, descrivendo il suo romanzo La sottile inquietudine delle guardie del corpo come «un tour de force impossibile da etichettare che è tanto avvincente quanto originale». Raccomandò anche Notturno di Manhattan (2007), un romanzo dell’editor di Harper’s con cui aveva lavorato in passato, Colin Harrison, tirando fuori ancora una volta dalla cassetta degli attrezzi l’aggettivo «spietato»:
Dotato di una spietata capacità di osservazione e di una trama struggente, Notturno di Manhattan è un libro godibilissimo su tutti i livelli: il miglior esempio di noir postmoderno dal Grande nulla di Ellroy.
E quando nel 2006 Antonya Nelson, con cui Wallace aveva studiato all’Università dell’Arizona e che aveva la sua stessa agente, pubblicò Some Fun: Stories and a Novella, Wallace scrisse che era «stato un fan di Toni fin da quando ho letto un suo racconto intitolato “The Salad” al secondo o terzo giorno di corso di specializzazione. Ho divorato la sua ultima raccolta così in fretta che le pagine sono bruciacchiate». Neanche queste, però, erano raccomandazioni buttate lì con leggerezza, dato che a quanto pare nel 2002 Wallace rifiutò di scrivere un blurb per una raccolta di saggi su Star Wars a cura di Glenn Kenny, con cui aveva precedentemente lavorato per un pezzo uscito su Premiere.
Nel corso di tutta la sua carriera, Wallace diede il suo sostegno anche a vari testi di non-fiction, che voleva aiutare a trovare un pubblico più vasto. Nel 2004 scrisse un blurb per The Middle Mind di Curtis White, un libro che riflette sul fallimento dell’immaginazione politica americana e critica aspramente la partigianeria di entrambi gli schieramenti, tesi che ben si sposa con le posizioni politiche da «Terza Via» dello stesso Wallace. In questo caso, Wallace rispolverò ancora una volta gli aggettivi «spietato» e «vero», descrivendo il saggio come «persuasivo, acuto, elegante, spietato e vero». (Wallace aveva trovato terreno comune con White già nel 1998, quando scrisse un blurb per il suo romanzo sperimentale Memories of My Father Watching TV definendolo «di un’intelligenza raggelante, di un umorismo grottesco, tristemente comprensivo e così commovente da straziare il cuore».) Come i racconti della Daitch, i libri di White erano pubblicati da Dalkey Archive, casa editrice per cui Wallace aveva una venerazione.
Wallace era anche palesemente innamorato del saggista e critico culturale Lewis Hyde, e scrisse due blurb per un testo di Hyde che analizzava l’immaginazione picaresca, Il briccone fa il mondo (1998). In uno di questi, Wallace sosteneva che «Lewis Hyde è un patrimonio nazionale, una delle vere superstar della nostra saggistica», ma forniva anche una versione più estesa di questo giudizio:
Lewis Hyde è una delle vere superstar della nostra saggistica: questo libro non solo affronta il suo argomento con un grado di profondità e di comprensione finora mai raggiunto (quantomeno dai libri che ho letto io), ma finisce anche per parlare di… be’, di tutto. L’autore è sia brillante (a livello intellettuale e letterario), sia maturo (psicologicamente, spiritualmente, quello-che-volete-mente).
Questo blurb in particolare mostra molte delle idiosincrasie stilistiche di Wallace, e richiama inoltre l’attenzione sulle stesse doti da lui già riscontrate nella Daitch e in Kalfus. Dato che il tentativo di combinare la perizia tecnica con l’autentica maturità di pensiero era palesemente stato uno degli scopi principali di Wallace per tutta la sua carriera, ha senso che lo scrittore fosse sempre pronto a riconoscere questa virtù nell’opera altrui. Secondo D.T. Max, Wallace aveva letto Alcohol and Poetry: John Berryman and the Booze Talking di Hyde alla fine degli anni Ottanta, ma aveva amato anche l’analisi fatta da Hyde dell’economia del dono e della pratica artistica in Il dono (1983), di cui scrisse un blurb per la ristampa Vintage del 1999. La sua breve ma significativa raccomandazione affermava che «nessuno che si dedichi a qualche genere di arte può leggere Il dono senza uscirne cambiato». Come hanno mostrato Max e vari altri studiosi, Wallace stesso era uscito senz’altro cambiato dalla lettura del libro di Hyde. Gli appunti ai margini della copia di Il dono conservata nel suo archivio testimoniano un intenso corpo a corpo con l’argomentazione di Hyde, che in definitiva lo spinse a ripensare il senso della sua stessa pratica artistica, vedendola come una sorta di regalo al lettore.
Un ultimo indizio sul tipo di non-fiction che Wallace ammirava ce lo fornisce il blurb che scrisse per la raccolta Halls of Fame di John D’Agata, uscita nel 2003, paragonandola all’opera di molti dei suoi saggisti preferiti della generazione precedente (fra cui proprio Hyde):
John D’Agata è uno degli scrittori più significativi emersi negli Stati Uniti negli ultimi anni. I suoi saggi uniscono l’innovazione e il candore di David Shields e William Vollmann alla perspicacia, la concinnità e la pura e semplice forza estetica di Annie Dillard e Lewis Hyde. In nessun altro libro recente viene percepita ed evocata in maniera così vivida la compresenza di merda e luce di cui è fatta l’America.
Oltre a contenere una nota di elogio decisamente improbabile (nei saggi di Wallace non sembra ci sia spesso una ricerca della «concinnità»), il blurb fornisce una descrizione indiretta di ciò che Wallace apprezzava nella saggistica letteraria. Ancora una volta, Wallace usava il blurb come un’opportunità per tracciare una complessa analisi di qualità letterarie, e usava la propria autorità per aiutare uno scrittore più giovane all’inizio della carriera.
Per completare l’elenco dei blurb di Wallace restano quelli che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie, e che risultano piuttosto anomali. Fra questi, una descrizione memorabile della comicità di Wodehouse sulla copertina di The Best of Wodehouse (2007) – che Wallace chiamò «di una spassosità e una cattiveria senza tempo» – e un endorsement spiritoso per una raccolta di saggi sul tennis curata da Jay Jennings, intitolata Tennis and the Meaning of Life: «L’unica critica che posso fare a questo libro è che il titolo è ridondante». Sempre in questa categoria rientra la promozione di un catalogo «SkyMaul», parodia di quelli «SkyMall» distribuiti in aereo, prodotto da un gruppo di comici di San Francisco chiamato Kasper Hauser e pubblicato in forma di libro da St. Martin’s Press. Il sito dei Kasper Hauser assicura ai lettori che la battuta di Wallace sulla maschera da toro da indossare per sfuggire ai controlli della polizia – «la maschera anti-etilometro funziona davvero!» – è «una frase scritta veramente da lui, non inventata».
E poi, ovviamente, ci sono anche i blurb ricavati opportunisticamente dagli editori a partire dalle recensioni e dagli articoli scritti da Wallace, come, fra gli altri, quelli che spiccano sulle copertine di La benda sugli occhi di Siri Hustvedt, Dead Elvis di Greil Marcus e Wittgenstein’s Mistress di David Markson. (Di gran lunga il più disonesto, fra questi, è una citazione decontestualizzata – «un piccolo capolavoro di lucidità» – sulla copertina di The Penguin History of Latin America di Edwin Williamson, l’unico complimento fatto da Wallace nella sua stroncatura di Borges: A Life dello stesso Williamson.) A questo punto, il nome di Wallace ha un tale peso che simili appropriazioni hanno perfettamente senso dal punto di vista del marketing.
***
Se la descrizione che Wallace fa del blurbspeak contiene molti degli stessi motivi di fastidio che tantissimi lettori hanno nei confronti del fenomeno dei blurb, è chiaro che quelli prodotti da lui offrono una prospettiva sui temi generali, gli obiettivi, i punti di forza e i difetti autodiagnosticati della sua scrittura molto più ricca di quanto di solito si pensi. Malgrado il suo profondo scetticismo rispetto a questo genere di testi, Wallace evidentemente prendeva molto sul serio le occasioni che aveva di scriverne. In quanto suoi ammiratori e lettori, dovremmo fare altrettanto.
© Lucas Thompson, 2015. Tutti i diritti riservati.
Condividi