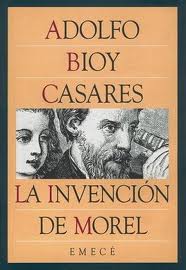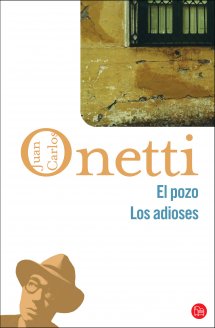È un fatto: un bel libro ne fa venire in mente un altro, e questo un altro ancora. Come annotava César Aira in un breve e denso saggio che compare negli archivi del blog «Il libro letterario fa sempre parte di una biblioteca. Isolato, vale ben poco in termini di piacere e sapere. Il vero simbolo dell’appassionato di letteratura non è il libro, ma la biblioteca. E questo si deve al fatto che la letteratura crea un sistema». È ciò che segna la differenza fra la letteratura (lasciamo perdere le maiuscole e gli aggettivi) e arti minori (vogliamo chiamarle così?), tipo l’intrattenimento letterario. Di nuovo Aira: «Al contrario, se uno legge un best seller, per esempio un romanzo sul contrabbando di materiale radioattivo nel Baltico, e gli piace… Anche se gli piace moltissimo, anche se è il libro che gli è piaciuto di più nella sua vita, è molto improbabile che gli venga voglia di leggere un altro romanzo sul contrabbando di materiale radioattivo, o sul contrabbando, o sul Baltico.»
Fabrizio Gabrielli ha letto Gli addii di Juan Carlos Onetti, ma non poteva parlarne senza evocare altri libri e altri autori… Adolfo Bioy Casares e Julio Cortázar, scusate se è poco. Buona lettura.
di Fabrizio Gabrielli
Son già stato qui, ma quando e come lo so mica (un incipit proustiano)
Ci sono istanti in cui, per dirla con Pavese, alziamo la testa e scopriamo, con stupore, la vita. A volte, quella vita abbiamo la sensazione come d’averla già vissuta, spremuta, d’averne succhiato l’essenza come da una caramella al rabarbaro, e proustianamente ci troviamo sulle papille sapori sperimentati, ossimorici deja vu.
Probabilmente non esistono mots justes per musicaleggiare quel gran bel concetto freudiano che travalica le barriere del deja vu per trascendere nel deja été – la familiare afamiliarità dell’unheimlich, del perturbante – migliori di quelle del poeta Dante Gabriele Rossetti:
I’ve been here before
but when or how I cannot tell
Mi sembra significativo che Jorge Luis Borges abbia citato questi versi nell’introduzione al romanzo breve di Adolfo Bioy Casares L’invenzione di Morel, che assurgerò qui a mia personalissima e contingente e glucòtica madelaine. C’è una scena, ne L’invenzione di Morel, a pagina 44, in cui compare della musica, un palazzo che potrebbe essere un manicomio, o un grand hotel, o ancora un sanatorio; e poi tutta una sensazione di malinconia astringente, nostalgicamente amara, come le radici di rabarbaro, questa:
“Tra i rumori cominciai a udire brani di una melodia concisa, molto remota… Non la udii più e pensai che era stata come quelle figure che, secondo Leonardo, appaiono quando guardiamo a lungo le macchie di umidità. La musica ritornò e io rimasi con gli occhi annebbiati, compiaciuto della sua armonia, sconvolto, prima che il mio terrore diventasse totale.
[…]
Qui abitano gli eroi dello snobismo (o i pensionati di un manicomio abbandonato). Senza spettatori – o forse sono io il pubblico previsto fin dall’inizio -, pur di essere originali oltrepassano i limiti della scomodità sopportabile e sfidano la morte. […]
Portarono fuori il fonografo dalla camera verde, attigua alla sala dell’acquario; uomini e donne, sedute su panchine o sull’erba, conversavano, ascoltavano musica e ballavano in mezzo a una tempesta di acqua e di vento che minacciava di sradicare tutti gli alberi.”
che è poi la scena che mi è subito venuta in mente quand’ho invece letto questo passo de Gli addii di Onetti, che è a pagina 49, e fa così:
“Qualcuno teneva la finestra aperta al primo piano dell’albergo; stavano ancora ballando, ridevano, e le voci si abbassavano bruscamente fino ad assumere un tono di addii, di confidenze conclusive; passavano ballando di fronte alla finestra, e il disco era La vie en rose, con accompagnamento di fisarmonica”.
Io non lo so se è saggio fidarsi e affidarsi alle parole di un poeta, per dare corpo a un presentimento, a una sensazione: il poeta è poi la più impoetica delle cose che esistono, lo diceva pure Keats, perché si lascia attrarre da tutti i colori e da tutte le luci, come fosse un camaleonte. E il camaleonte non lo sa mai, di che colore sia precisamente la verità, perché su ogni cosa su cui si posa, a conti fatti, finisce per riconoscerne una sfumatura, della verità, una sua parte.
Nondimeno riconosco l’utilità di abbandonarsi, come suggeriva Cortázar mutuando un concetto di Coleridge, alla pratica della sospensione dell’incredulità, unica vera via per addentrarsi nei meandri del fantastico: farsi complici, e anche un po’ camaleonti, accontentandosi di leccarla soltanto, la verità, di sfuggita, senza la pretesa di fagocitarla.
Che poi, in un certo senso, è quel che capita anche ai personaggi de Gli addii di Juan Carlos Onetti, mi sembra di poter dire: la camaleontizzazione, intendo; la sospensione dell’incredulità, dico.
Da subito, le mani
Il plot de Gli addii muove da un evento estremamente ordinario nella sua straordinarietà, e viceversa: nella tranquillità polverosa di un villaggio di montagna, in un dove e in un quando imprecisato, irrompe come una delle visioni nell’isola de L’invenzione di Morel, impalpabile come un ologramma, un uomo di mezza età, dalla consistenza eterea, quasi evanescente: viene per curarsi dalla tisi.
Ha la faccia di legno duro, imperturbabile, e gli occhi da pesce addormentato. Lo seguiranno e raggiungeranno, nel dipanarsi della vicenda, due donne, diversi modelli di femminilità, che è poi un tratto ricorrente, nella narrativa onettiana: una adulta, già madre, vissuta, che sembra averne scartate già molte, di caramelle al rabarbaro, e pure qualcuna alla cicuta; e una invece appena uscita dalla pubertà, lolita pudica che potrebbe essere sua amante, figlia, cugina, sorella. Eppure, nessuna di loro riuscirà mai a sottrarre dalla gloria del proscenio l’uomo, che si scoprirà più avanti essere un ex giocatore di basket di successo, e più significativamente un dettaglio, dell’uomo. Le sue mani. Protagoniste fin dall’eccelso incipit. Mani che non mentono, né si sottraggono. Mani – straordinariamente ordinario strumento di quotidianità – che sembrano essere le vere padrone di ogni scelta. Mani che da subito catturano lo sguardo del narratore e del lettore, dando ad intendere che sarà da loro che dipenderà ogni scelta di gioco, ogni azione di guardia, ogni tiro da tre punti, per dare continuità alla metafora baloncéstica.
Mani che, penelopicamente, hanno il potere taumaturgico di fare e disfare ogni matassa.
Tra «Casa occupata» e Gli addii
Il quotidiano, nel villaggio di montagna, e ancor più specificatamente nella pulpería gestita (e frequentata) dal narratore (e dal coro di narratori), è un continuo rincorrersi ciclico di arrivi e partenze, avventori che non cambiano mai, ciarle vuote, sospetti e maldicenze sempre uguali a se stesse. In una tela di maglie tessute a memoria, in un reticolo di birre servite a occhi chiusi, di risposte automatiche a domande-carta-carbone, l’irruzione dello straordinario, diremmo del “fantastico”, non scombina la realtà, non la stravolge: semplicemente, e al contempo meravigliosamente, la ridefinisce. L’elemento perturbante non annichilisce il quotidiano: tutt’al contrario, da questo trae linfa vitale, se ne nutre, ne solletica le corde più recondite. La normalità si fa combustibile perfetto per generare, al presentarsi dell’innesco, l’effetto straniante, come i girasoli nel giardino di Lovecraft quando, di punto in bianco, si mettono a cantare.
Uno dei racconti che più trasuda unheimlich (fortunatamente citato durante una presentazione de Gli addii di Onetti cui son stato presente, e a dirigere i giochi era Cristian Bufi) è «Casa occupata» di Julio Cortázar. In quel racconto, la voce narrante e Irene vivono un rapporto perturbante, che l’autore definisce a un tratto “matrimonio di fratelli”, in una casa grande, molto grande, fin troppo grande (non è da escludere che Onetti, ne Gli addii, abbia voluto rendere omaggio alla casa occupata cortazariana tessendo attorno alla baita di montagna in cui si rifugiano il personaggio principale e una delle due donne, in precedenza abitata da tre cugine suicide, un’aura misteriosa, quasi “fantasmatica”). La citazione del racconto cortazariano era sortita, durante quella presentazione, in merito alla sottrazione: in «Casa occupata», un’entità misteriosa ruba spazi, divora stanze, occupa interstizi e ricordi, li sottrae ai legittimi proprietari; e ai personaggi non resta che riconoscere come un dato di fatto la privazione, accettare la fagocitazione di una fetta dopo l’altra di ordinarietà, fin quando, in extrema ratio, non si vedranno costretti ad abbandonarla del tutto, la casa, ormai in possesso dell’entità misteriosa.
Esistono molti punti di contatto tra il racconto cortazariano e il romanzo breve onettiano, anche a un livello superficiale, non tutti emersi durante quella presentazione.
Il sussurro di conversazioni contro le porte di legno, i pisipigli senza spazio e senza tempo, le voci di statua e di pappagallo che risuonano nella casa occupata hanno la stessa dimensione mitica del pettegolezzo, dell’illazione che caratterizza la trama onettiana.
E poi l’acme narrativo incentrato sulla notte. In Onetti qualsiasi cosa avviene col buio, l’ambientazione predominante è quella di locali nel momento che precede la chiusura, o in cui sono deserti, sopiti, quello spazio liminale tra “la baldoria e la notte”. La «Casa tomada» diventa del tutto tomada alle undici di sera. Tutte le scene madri de Gli addii avvengono dopo il tramonto, a volte con l’asse temporale spostato verso l’alba.
La notte assume i connotati di terra neutra, in cui i destini si incrociano e nondimeno regna sovrana la sensazione che mai siano stati, sono, saranno in qualunque modo intrecciati. Il crepuscolo, in Cortázar, così come la notte, in Onetti (e anche il cambio di marea, in Bioy Casares) appaiono come lo spartiacque tra la fine di una vita e il principio di un’altra, ma senza possibilità di redenzione, o di presa di coscienza delle azioni compiute in passato: ogni notte è occasione per constatare l’impossibilità, per l’uomo, di incontrare davvero il proprio destino. Ogni legame nato nell’oscurità è fallace, ed esistere, ecco, esistere è un continuo malinteso, un sogno che ricordiamo male, o che non ricordiamo affatto: la nostra esistenza, dopotutto, non vale più di un sogno altrui, come scrive Onetti.
In entrambe le storie la dimensione narrativa ha i contorni sfocati dello spaesamento, della perdita di cognizione del tempo, dell’allucinazione, quella che sopraggiunge con la spossatezza e la fame (come accade al personaggio de L’invenzione di Morel di Bioy Casares), quella che t’attanaglia quando la luna è molto alta, e ti risvegli, e finisci per non realizzare dov’è che ti trovi (non nel living, Irene, il living è già occupato).
Si tratta di quell’allucinazione onirica che, tra sogno e veglia, ti rende suppostamente onnipotente; ogni storia, allora, sembra finisca per dipanarsi su canovacci meticolosamente sceneggiati, i personaggi sono manichini simili alle bambole del racconto Le ortensie di Felisbérto Hernàndez o agli ologrammi inventati dal Morel di Bioy Casares, sei ancora camaleonte, certo, ma ebbro e senza bussola: “mi sentivo investito di un grande potere, come se l’uomo e la ragazza, e anche la donna matura e il bambino, fossero nati dalla mia volontà per vivere ciò che io avevo deciso”, riconosce a un tratto la voce narrante de Gli addii.
Vacuità da occupare, vacuità da riempire
Ma più nel profondo, «Casa occupata» ha in comune con il romanzo breve di Onetti il tema della sottrazione.
Ne Gli addii ogni narratore è parziale, ed è come se recitasse il suo cammeo di camaleonte: l’unica approssimazione possibile alla storia è fatta di verità relative, e necessariamente la narrazione è per sottrazione, per occupazione di stanze.
Si direbbe che la forza profonda che anima la trama sia lo sforzo che si compie per riempire una vacuità. Nella fattispecie, quella generata della solitudine.
Ogni isolamento è, per definizione, concavo: e l’uomo avverte, in sua presenza, la necessità di riempimenti convessi, per quanto artefatti. La loquacità con la quale nel romanzo l’uomo riempie il primo incontro in terra neutra con la donna matura, l’euforia dei festeggiamenti di capodanno, l’animalesco agire dei tubercolotici del sanatorio, le veglie protratte, le vigilie vissute con intensità, ogni azione sembra volta a insufflare senso in parole, commiati, lettere scritte e non scritte, discorsi detti e non detti, altresì vuoti.
La solitudine chiama pietà, protezione, pazienza, scatena tutta una serie di varianti della preoccupazione e la preoccupazione, si sa, la maniera migliore per esorcizzarla è proferire parole, rassicurazioni flebili, riempire gl’interstizi di silenzio.
Nel sanatorio, nessuno parla con l’uomo, e se gli parlano è per scherzarlo: “quello non saluta nessuno, ma nessuno vuole parlare male di lui”.
Eppure, tutti avvertono l’obbligo morale – panacea spicciola – se non di parlarGli, almeno di parlarNe. Gli altri malati lo schivano perché lui rifiuta le cure, non accetta il proprio destino, perché si rifiuta di sentirsi parte di una comunità. Perché coltiva la sua enclave concava refrattario all’altrui convessità.
Il personaggio de Gli addii ricorda molto da vicino quello de Il pozzo, il primo romanzo breve di Onetti, dipinto come un uomo solitario che fuma in un posto qualunque della città mentre la notte lo avvolge e si compie un rito, quello della vita, da contemplare con distacco, come un qualcosa con cui lui sembra non avere davvero nulla a che fare.
Per Onetti il più grande effetto (e forse vantaggio) della solitudine è quello di trovarsi nella condizione di non essere più nulla (e questa vocazione all’isolamento, all’indifferenza, a dire di Mario Benedetti, è stato anche un tratto saliente della vita di Onetti, tenutosi ostinatamente a margine di gruppi, riviste, manifesti, impegno civile).
Una siffatta vacuità, generata attraverso l’allontanamento volontario – ma forse già insita nell’animo – fa sì che l’uomo diventi un individuo solitario e indesiderabile, superiore ai propri scrupoli e alla propria vigliaccheria, ma irrimediabilmente inferiore al proprio mondo immaginario, contenitore senza contenuti, “solo corpo”.
E quando si è solo corpo, pura materialità, quando ci si fa oggetto, ogni addio si spoglia dalle implicazioni sentimentali e ideologiche, diventa mero meccanismo di allontanamento fisico. Angoli che si separano, creando un interstizio tra il concavo e il convesso.
Ogni isolamento è, per definizione, concavo: e l’uomo avverte, in sua presenza, la necessità di riempimenti convessi, dicevo.
Poi, poi la felicità è tutt’un altro paio di maniche. Casomai riusciamo a trovarla nella lontananza da tutto e da tutti. Casomai no.
Ed è in quel caso, quando la solitudine anziché sollevarci ci pesa, che siamo altresì capaci di compiere tutte le vigliaccherie atte a procurarci compagnia.
Come ostinarci a convivere in una casa sotto assedio, con una donna che amiamo non amandola davvero, aspettando l’inevitabilità del giorno in cui qualcosa arriverà a occuparci vita e villa, ch’è ciò che accade in «Casa occupata».
Oppure potremmo cercare i meccanismi che permettono agli eroi dello snobismo di vivere una quotidianità sempiterna fatta di ombre ectoplasmatiche e susseguirsi d’ologrammi, come ne L’invenzione di Morel.
O ancora, e infine, per provare a sentirci un po’ meno soli, potremmo lasciarci coinvolgere dal chiacchiericcio maligno attorno a quell’uomo misterioso, che s’è introdotto nelle nostre vite e che rifiuta di curarsi.
Dalla tubercolosi, ma fors’anche, a guardar meglio, in ultima istanza, dalla sua stessa solitudine.
Condividi