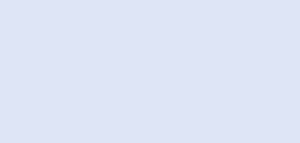 Questo articolo è originariamente apparso sulla Paris Review; ringraziamo l’autore e la testata.
Questo articolo è originariamente apparso sulla Paris Review; ringraziamo l’autore e la testata.
di R.J. Hernández
traduzione di Daniela De Lorenzo
Se provate a chiedere in giro chi è Seymour Glass, vi risponderanno «un personaggio di Salinger»: il primogenito della precoce famiglia Glass, un misantropo che – nel racconto «Un giorno ideale per i pescibanana» – si spara durante una vacanza. Ma provate a chiederlo a qualcuno che lavora nel mondo della moda a New York – specie se nella redazione di qualche rivista patinata – e potreste sentirvi dire: «Ma non è quello che lavorava qui?»
È a me che si riferiscono.
Il mio nome di battesimo è Ricardo Rolando Hernández. Quando avevo nove anni, in occasione della mia Cresima – la cosiddetta Confermazione della fede cattolica – un ulteriore nome si intrufolò tra Rolando e Hernández: Jesús, ovviamente. Si completava così una combinazione di sillabe che non lasciava dubbi sulle mie origini ispaniche e avrebbe portato alla mia crisi d’identità come cubano-statunitense.
Questa crisi era un mio diritto di nascita: è un tipico marchio di fabbrica dei cubani. Da un lato, ricordano con orgoglio l’opulenza della vita tropicale che conducevano prima della revolución, un quadretto sbiadito di salsa, palme e café con leche in mezzo ai palazzi e ai colonnati scolpiti dell’Habana Vieja. Dall’altro, si vergognano per quanto è accaduto dopo: le privazioni, l’esilio e la perdita di quella vita quando si sono visti costretti a ricominciare da zero su un’altra isola, ben diversa.
A differenza del resto della mia famiglia sradicata – come tanti altri cubani eravamo finiti a Miami – mia madre è nata negli Stati Uniti.
Per questioni di pragmatismo, pensava che il mio nome spagnolo dovesse essere l’unica concessione alla mia metà «inferiore» e mi fece conoscere una variazione sul tema di un’idea condivisa da un certo Nick Carraway: le opportunità in America, così come le regole basilari del buon gusto, sono distribuite in modo disuguale sin dalla nascita. E la maggior parte di quelle opportunità erano destinate a gente bianca e ricca, non ai sudamericani né tantomeno alla prole degli esuli cubani.
Ne conseguì un profondo odio per me stesso e, in primis, verso quello che era il mio nome. A qualcun altro il nome Ricardo Rolando Jesús Hernández poteva forse piacere, è solenne, trionfale, e sembra richiamare la tradizione dei conquistadores spagnoli. Ma a me non stava bene. Vedermi affibbiare un nome così mi sembrava una beffa, dato che desideravo soltanto sottrarmi all’inferiorità che denotava.
Era come se fossi costretto a indossare un paio di scarpe che mi facevano male, e di uno stile che non mi piaceva. Sapevo di non poterlo cambiare; ero troppo giovane e non avevo idea di come fare. Crescendo, però, iniziai a rendermi conto che forse potevo intervenire su altri aspetti di me stesso. Fu così che ebbe inizio il mio interesse per la moda: cambiare abiti mi sembrava una comoda alternativa al cambiare identità. Mi abbonai a Esquire e azzardai un folle abbigliamento a strati sotto il sole di Miami. Poi, quando andai a Yale, assaltavo ogni settimana i negozi dell’usato di New Haven – era una specie di rituale – alla ricerca degli indumenti smessi dei WASP: giacche del college, cardigan a trecce, cravatte ricamate con piccole balene e barche a vela.
La moda creava una barriera tra la percezione che la gente aveva di me e il mio vero io; mi permetteva di farmi passare per qualcun altro. L’ultimo anno ero ormai molto simile al Povero di Twain, tutto infiocchettato negli abiti sgargianti del Principe e pur sempre senza sangue reale.
Non sapevo cosa fare dopo la laurea, o meglio sapevo solo di voler fare qualcosa nel campo dell’arte o della moda e tuffarmi nell’attraente baraonda di un tipo di vita che fino ad allora mi era sfuggita. Quella vaga premessa iniziò ad assumere una forma più concreta quando riuscii a trovare uno stage presso una prestigiosa rivista di moda.
Prima di iniziare mi feci confezionare tre abiti su misura da un sarto di New Haven, con tessuti molti ricchi, broccato lucido e seta orientale – l’investimento più costoso della mia giovane vita, nonché l’inizio di un nuovo tipo di guardaroba. In quel periodo leggevo i Nove racconti di Salinger, in cui Seymour Glass fa la sua breve apparizione. Ricordo che pensai: non sarebbe fantastico avere un bel nome d’altri tempi come Seymour? Allungare la mano e presentarsi come Seymour avrebbe lasciato intendere non solo che eri bianco, ma anche che eri un bianco di quelli spocchiosi, ricchi da generazioni e con una grandiosa tradizione alle spalle. La tua famiglia poteva essere ebrea, o francese, o magari inglese; ad ogni modo sarebbe sempre stato meglio di ciò che realmente ero.
Mi informai su come cambiare nome. Non richiedeva chissà quale sforzo: se volevi un nome nuovo, non avevi che da iniziare a usarlo. Sapevo per certo di voler essere un Seymour, ma quando iniziai ad affiancarlo ai possibili cognomi, mi resi conto che nessuno era meglio di Glass. Per un’immaginaria famiglia ebrea integratasi a New York all’inizio del Ventesimo secolo, il nome Glass era problematico almeno quanto lo era il mio nella vita reale; applicarlo su di me, invece, sembrava una soluzione poetica. Potevo nascondermi in bella vista nel rifugio lucente di una parola come glass, vetro. Ero attratto da quella simmetria perfetta: un nome disonorevole che cancellava il disonore del nome precedente, un ponte attraverso i decenni, tra la realtà e finzione, tra volere e valere.
Il passaggio da un nome all’altro avvenne in modo un po’ goffo. L’assistente che mi aveva fatto il colloquio conosceva il mio vero nome – come anche quelli delle risorse umane – e nonostante le avessi chiesto di chiamarmi Seymour, molto spesso se lo scordava. Il giorno in cui un importante fashion editor fece la sua comparsa in ufficio – un dandy inglese con baffi a manubrio, appena tornato da una vacanza e che vagava qua e là come una trottola smarrita – l’assistente mi chiamò con il nome sbagliato, Ricardo.
L’editor stava rovistando tra le montagne di documenti che aveva sulla scrivania, alla ricerca di qualche appunto fuori posto. «Pensavo ti chiamassi Seymour», mi disse, riferendosi al nome che avevo utilizzato nelle mail. Diventai tutto rosso. La rivelazione del mio vero nome annullò il potere di quello nuovo, vanificò l’obiettivo. Annuì distratto mentre cercavo di spiegargli. Poi borbottò qualcosa all’assistente a proposito di mettere della naftalina nell’armadio e se ne andò un’altra volta, doveva prendere un aereo per il matrimonio di una top model in qualche improbabile contea inglese. Trascorsi il resto della settimana confinato alla scrivania, assorbito dai lavori più noiosi, e l’unica opportunità per interagire con qualcuno mi si offriva alla cassa della mensa.
Sembrava che l’occasione di presentarmi di nuovo a qualcuno non arrivasse mai – figuriamoci quella di reinventarmi – finché non arrivò un altro pezzo grosso della redazione, anche lui di ritorno da una vacanza. Un personaggio sopra le righe e lezioso almeno quanto il primo; faceva sempre gran bei discorsi sullo stile e indossava mantelli eleganti che frusciavano al suo passaggio.
La prima volta che ci incontrammo posò gli occhi sul mio completo orientale e, stupefatto, per poco non scoppiò a ridere: Chi sei?, mi chiese. Glielo dissi, e da allora in poi prese l’abitudine di chiamarmi nel suo ufficio per scambiare quattro chiacchiere, e perché gli sistemassi il computer.
La mia visione di Seymour Glass contrastava con quella di Salinger. Ero cento volte più precoce, con gli occhiali spessi e rotondi e i riccioli castani in disordine. Nei miei abiti a fantasia con plastron coordinato, l’unica cosa che mi accomunava con il Glass di Salinger era uno stesso idealismo a pois.
Riscrivendomi un’identità, e di conseguenza una storia personale, avevo sperato di confermare l’esattezza delle parole dette da mia madre anni prima – che le occasioni più importanti avrebbero forse bussato alla porta della parte «migliore» di me – e, sorprendentemente, fu ciò che accadde. Non potevo sapere se anche con i vestiti usati di un tempo e con il nome Ricardo avrei avuto la stessa fortuna, ma ero convinto che la trasformazione in Seymour avesse fatto la differenza. Come se stessi spuntando casella dopo casella l’elenco del migliore scenario possibile, arrivò anche l’invito da parte del mio esuberante capo a partecipare con lui alla Fashion Week.
A quell’epoca la settimana della moda veniva inaugurata in tutta la città con un evento chiamato Fashion’s Night Out, durante il quale gli appassionati di moda passavano da un negozio all’altro in pompa magna, per una serata all’insegna dello stile. Indossai il completo in broccato e mi incontrai con il mio capo nella boutique di Manolo Blahnik, dove una fila di gente aspettava di poter parlare con lui e con una famosa attrice. Ero al suo fianco da un quarto d’ora – dietro di lui, in realtà, mentre intratteneva i suoi ammiratori – quando mi si avvicinò la telecamera di un canale dedicato al mondo dello spettacolo. Un intervistatore mi chiese: «Chi indossa?», tendendomi il microfono. La luce bianca mi inondò gli occhi, sentii il battito accelerare e mentii, dicendo che lo stilista che aveva creato il mio abito era Gucci. Per tutto il resto della serata mi sentii davvero qualcuno – Seymour Glass, firmato Gucci da capo a piedi, accanto al celebre fashion editor suo amico –, quasi me ne convinsi sul serio, e mentre ce ne andavamo in giro da un evento all’altro a bordo di un’Escalade nera, saltellando di conversazione in conversazione, continuavo a inventare altre bugie per star dietro alla mia messinscena: «Donatella? Ma certo che la conosco!», «Adoro Cannes, però la preferisco quando non c’è il festival». Qualche giorno dopo, nel backstage della sfilata di Diane Von Furstenberg, lei mi chiese se ci fossimo già incontrati. Ridendo le confermai che sì, in effetti ci eravamo già visti un paio di volte.
Esaltato dalla fantastica immagine che avevo costruito di me stesso, continuai a frequentare le feste più chic anche nelle settimane che seguirono. Ad ogni occasione mettevo in evidenza il mio ottimo pedigree da studente di Yale che aveva viaggiato in lungo e in largo sin da piccolo – quando il posto più lontano che avevo visto in realtà era Disney World. Anche se il mio nome suscitava spesso curiosità, nessuno ne riconosceva mai l’origine letteraria. Se avessi deciso di chiamarmi Balenciaga avrei forse visto qualche sopracciglio alzarsi, ma in questo mondo, evidentemente, Salinger non era poi così importante. Non avevo nessuno scrupolo a farmi passare per un altro, in qualche modo lo facevano tutti, o no? E se questa cosa non danneggiava nessuno, perché mai avrei dovuto dire la verità, convinto com’ero che la verità avrebbe danneggiato me?
Mi dicevo che gli altri non avevano fatto nulla per meritarsi i vantaggi che la semplice nascita gli aveva assicurato. Stavo solo cercando di giocare ad armi pari; e intanto mettevo tutto per iscritto. Dato che ho una pessima memoria, ho sempre avuto l’abitudine di portare con me un piccolo taccuino, una specie di diario stenografico. In quel periodo consumai taccuini su taccuini, annotavo ogni minimo dettaglio interessante: cosa dicevano le persone, come si comportavano, dove andavano a mangiare, a divertirsi, o in vacanza. Facevo del mio meglio per trascrivere intere conversazioni, cercando di memorizzarle abbastanza a lungo finché non riuscivo a rifugiarmi nel bagno più vicino. Ero come stregato.
In ufficio avrei forse dovuto pormi qualche limite. Invece no, i miei look si facevano sempre più audaci. Ispirato da Andreja Pejic, la modella transessuale che si descrive come una persona che vive «tra i generi», iniziai a indossare scarpe da donna – stivaloni a punta col tacco alto. Di sicuro fu quello il momento in cui oltrepassai il segno, anche se non me ne resi affatto conto finché non fu troppo tardi. Dopo il caso di Caitlyn Jenner, un uomo che indossa i tacchi può sembrare una cosa banale, ma all’epoca, in mezzo al trambusto per il matrimonio tra persone dello stesso sesso e per la politica del «non chiedere, non dire» in ambito militare, era un attacco alle convenzioni evidentemente troppo sfrontato per quei miei colleghi incatenati alle scrivanie, che osservavano le mie bravate da lontano, per nulla divertiti.
Non avevano bisogno di un motivo ufficiale per mandarmi a casa. L’espressione che continuò a perseguitarmi fu «rendendoti ridicolo», seguita da qualcosa su come quella gente non lavorasse nella moda «accettabile» da anni per vedere me, uno stagista, andarmene in giro a battere i tacchi come se facessi parte di quel mondo.
Quella sconfitta scatenò una brusca discesa negli inferi. Prima ci fu una fase di negazione – ero sorpreso e incredulo –, poi seguì la rabbia, sotto forma di determinazione violenta e presuntuosa a «farcela» altrove, a far capire finalmente a chi mi aveva respinto il grande errore commesso. Mi candidai come stagista presso decine di riviste in tutta Manhattan e, non ricevendo nessuna risposta, mi resi conto di quanto fosse rara l’occasione che mi ero appena fatto sfuggire dalle mani.
Come una cometa finita fuori rotta dopo la fiammata della mia breve carriera, fluttuavo senza scopo. L’ambizione aveva lasciato il passo alla paura, alla mancanza di fiducia in me stesso, all’ansia di sempre: che senza l’illuminazione da parte di un astro più grande che mi legittimasse – un college prestigioso, un lavoro prestigioso o un nome prestigioso – ero un buco nero, un signor nessuno.
Scegliendomi il nome di un veterano di guerra suicida con disturbi post-traumatici da stress, era come se fossi entrato a far parte di una stirpe maledetta da qualche antica profezia. E dopo un paio di settimane buie, all’improvviso avevo in comune molto più di quanto pensassi con il tormentato Seymour di Salinger.
La depressione si era già manifestata in passato – da ragazzo le mie ambizioni burrascose mi provocavano molta tensione – ma anche nei momenti peggiori le cose non mi erano mai sembrate così fosche. Per placare l’agitazione che mi era esplosa dentro, uscivo tutte le sere e bevevo smodatamente – un vizio che ai tempi del college era sempre giustificato da qualche evento da festeggiare ma che adesso era solo un modo per autodistruggermi. Una notte, sul tardi – saranno state le due o le tre del mattino –, quell’insensata disperazione raggiunse il suo apice e mi ritrovai solo, ubriaco e barcollante per Central Park.
Chi diavolo ero? Dove volevo arrivare? Mi sentivo come un pescebanana, nuotavo sempre più giù, nel fondo di una fossa da cui non sarei mai riemerso. Il Seymour di Salinger si era completamente impossessato di me.
Convinto che mi restasse una sola cosa da fare, finii su un viale alberato nell’Upper East Side, scelsi quello che mi sembrava l’edificio più alto e varcai la soglia. Avevo l’impressione che l’intero palazzo mi oscillasse sotto i piedi.
Pavimento in marmo. Modanature bianche. Il bagliore delle rifiniture dorate mentre correvo verso l’ascensore più vicino.
Avrei premuto il pulsante ^, sarei andato su, su, sempre più su. E poi sarei saltato, maledizione. Avrei rinunciato all’idea di farcela, di essere qualcuno.
«Mi scusi!»
Mentre le pareti sembravano piegarsi, ricordo di aver puntato lo sguardo sui suoi guanti bianchi – «Chi sta cercando?», mi chiese il portinaio.
Nessuno, naturalmente. Devo essere inciampato mentre gli andavo incontro, ed essergli sembrato sperduto e patetico, perché mi tirò su con entrambe le mani e si offrì di chiamarmi un taxi. Se ce l’avessi fatta a raggiungere il tetto, sono certo che mi sarei accasciato a terra per autocommiserarmi, troppo triste e spaventato per saltare, dopodiché mi sarei svegliato con l’alito di whisky e un profondo disgusto per me stesso. E invece, dopo il momento più Seymour Glass della mia vita, tornai nel mio appartamento e scrissi questa frase: «Piena com’è di palazzi altissimi, pensavo fosse più facile uccidersi a New York».
Quella stessa settimana un’altra rivista mi offrì un lavoro e, tre anni e molte frasi dopo, quella primissima frase è diventata la battuta d’apertura del mio primo romanzo, An Innocent Fashion.
«Vogliono pubblicarti il libro», mi ha detto il mio agente al telefono, «a condizione però che sia firmato a tuo nome, non come Seymour Glass».
A quel punto ero ormai esausto di essere continuamente in bilico sul filo di Seymour Glass. Era come una performance artistica durata troppo a lungo e dove il minimo passo falso mi avrebbe fatto fare un bel salto e precipitare giù. Inoltre, da un po’ di tempo avevo iniziato ad avere qualche dubbio su chi fosse il «vero» me, Ricardo o Seymour. E dopo aver trascorso così tanto tempo circondato da quella gente a cui desideravo assomigliare, non riuscivo nemmeno più a ricordare per quale motivo volessi essere uno di loro.
E così, Seymour Glass è morto un’altra volta.
© R.J. Hernández, 2016. Tutti i diritti riservati.
R.J. Hernández è autore di An Innocent Fashion (HarperCollins 2016).
Condividi

